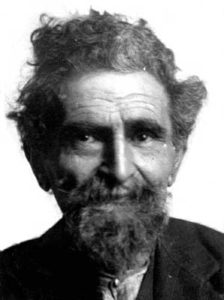Errico Malatesta – Al Caffe’
Scarica
–Errico Malatesta – “Al caffè” (pdf)
Errico Malatesta: Al caffè – Discutendo di rivoluzione e anarchia – Parte prima
Capitolo I
Prospero (grasso borghese intinto di economia politica ed altre scienze). – Ma sì… ma sì… lo sappiamo. C’è la gente che muore di fame, le donne che si prostituiscono, i fanciulli che muoiono per mancanza di cura . Tu dici sempre la stessa cosa… diventi noioso alla fine! Lasciaci sorbire in pace i nostri gelati… Sì, vi sono mille mali nella società; la fame, l’ignoranza, la guerra, il delitto, la peste, l’accidente che ti spacca… e poi? Che cosa t’importa a te?
Michele (studente che bazzica coi socialisti e gli anarchici). – Come! e poi? Che cosa m’importa?
Voi avete casa comoda, ricca mensa, servi al vostro comando. Voi mantenete i figli al collegio, mandate la moglie ai bagni; per voi tutto va bene. E purché stiate bene voi, caschi pure il mondo, non ve ne importa nulla. Ma se aveste un po’ di cuore, se…
Prospero. – Basta, basta… Non ci fare la predica ora… E poi, finiscila con questo tono, giovanotto. Tu mi credi insensibile, indifferente ai mali altrui. Invece il mio cuore sanguina (cameriere, porta un cognac ed un avana); ma col cuore non si risolvono i grandi problemi sociali.
Le leggi della natura sono immutabili e non v’è declamazioni, non v’è sdilinquiti sentimentalismi che possan farci qualche cosa. L’uomo saggio si piega al fatto, e cava dalla vita il meglio che può senza correr dietro a sogni insensati.
Michele. – Ah! si tratta di leggi naturali?… E se mo i poveri si mettessero in testa di correggerle loro queste… leggi di natura. Sento della gente che fa dei discorsi davvero poco rassicuranti per queste signore leggi.
Prospero. – Già, già, sappiamo bene con che gente pratichi. Dì pure da parte mia a quella canaglia di socialisti e di anarchici, di cui tu fai la tua compagnia prediletta, che per loro e per quelli che fossero tentati di mettere in pratica le loro teorie malvagie, abbiamo dei buoni soldati e degli ottimi carabinieri.
Michele. – Oh! se mettete in mezzo i soldati ed i carabinieri, io non parlo più. Tant’è come se per dimostrarmi che ho torto mi proponeste una partita a cazzotti. Però se non avete altro argomento che la forza brutale, non vi ci fidate. Domani potreste trovarvi i più deboli: e allora?
Prospero. – Allora? Allora, se questo disgraziatamente avvenisse, vi sarebbe un gran disordine, un’esplosione di cattive passioni, stragi, saccheggi… e poi sì tornerebbe come prima. Forse qualche povero sarebbe diventato ricco, qualche ricco sarebbe caduto nella miseria, ma in totale non vi sarebbe nulla di cambiato, perché il mondo non può cambiare. Menami, menami qualcuno di cotesti tuoi agitatori anarchici e vedrai come te lo concio. Sono buoni a riempire la testa di bubbole a voialtri che ce l’avete vuota; ma vedrai se con me potrà sostenere la loro assurdità.
Michele. – Va bene. Io vi menerò qualche mio amico che professa i principi socialisti ed anarchici ed assisterò con piacere e profitto alla vostra discussione, intanto ragionate un po’ con me, che non ho ancora opinioni ben formate, ma veggo però chiaramente che la società, così come è oggi organizzata, è una cosa contraria al buon senso e al buon cuore. Via, siete così grasso e florido che un po’ di eccitazione non può farvi male. Vi aiuterà la digestione.
Prospero. – E sia pure; ragioniamo. Ma quanto sarebbe meglio che tu pensassi a studiare invece di sputar sentenze in cose che preoccupano gli uomini più dotti e più savii! Sai che ho venti anni più di te?
Michele. – Questo non prova ancora che voi abbiate studiato di più, e se debbo giudicare da quello che d’ordinario vi sento dire, dubito che se anche avete studiato molto, lo abbiate fatto con profitto.
Prospero. – Giovanotto, giovanotto, badiamo al rispetto, eh!
Michele. – Ma sì, io vi rispetto. Però non mi buttate in faccia l’età, come poc’anzi mi opponevate i carabinieri. Le ragioni non sono né vecchie, né giovani; sono buone o cattive, ecco tutto.
Prospero. – Bé, bé, tira innanzi. Che cosa hai da dire?
Michele. – Ma, ho da dire che non so comprendere perché i contadini che zappano, seminano e raccolgono non hanno né pane, né vino, né carne a sufficienza; perché i muratori che fanno le case non hanno un tetto sotto cui ripararsi, perché i calzolai hanno le scarpe rotte; perché insomma quelli che lavorano, che tutto producono, mancano del necessario; mentre quelli che non fanno nulla gavazzano nel superfluo. Non so comprendere perché v’è della gente che manca di pane, quando vi sono tante terre incolte e tanta gente che sarebbe felicissima di poterle coltivare; perché v’è tanti muratori a spasso mentre tante persone hanno bisogno di case; perché tanti calzolai, sarti, ecc. sono senza lavoro, mentre la maggioranza della popolazione manca di scarpe, di abiti e di tutte le cose necessarie alla vita civile.
Potreste dirmi qual è la legge naturale che spiega e giustifica queste assurdità?
Prospero. – Niente di più semplice e chiaro. Per produrre non bastano le braccia, ma ci vuole la terra, ci vogliono i materiali, ci vogliono gli arnesi, i locali, le macchine e ci vogliono anche i mezzi per vivere aspettando che il prodotto sia fatto e si possa portare sul mercato: ci vuole insomma il capitale. I tuoi contadini, i tuoi operai non hanno che le braccia; per conseguenza non possono lavorare se non piace a chi possiede la terra ed il capitale. E siccome noi siamo pochi e ne abbiamo abbastanza anche se lasciamo per un pezzo incolta la nostra terra ed inoperosi i nostri capitali, mentre i lavoratori sono molti e sono stretti sempre dal bisogno immediato, così avviene che questi debbono lavorare quando e come piace a noi ed alle condizioni che a noi piacciono. E quando noi non abbiamo bisogno del loro lavoro e calcoliamo di non guadagnar nulla a farli lavorare, essi son costretti a restar inoperosi anche quando hanno il più grande bisogno delle cose che potrebbero produrre.
Sei contento ora? Vuoi che te la dica più chiara di questa?
Michele. – Sì, questo si chiama proprio parlar chiaro, non c’è che dire.
Ma con che diritto la terra appartiene solo ad alcuni? Come va che il capitale si trova in poche mani, e precisamente nelle mani di coloro che non lavorano?
Prospero. – Sì, sì, so tutto quello che puoi dirmi, e so pure le ragioni più o meno zoppe che altri ti opporrebbero: il diritto di proprietà derivato dalle migliorie apportate alla terra, dal risparmio mediante il quale il lavoratore si trasforma in capitalista, ecc. Ma a me piace essere più franco.
Le cose così come stanno sono il risultato dei fatti storici, il prodotto di tutta la secolare storia umana. Tutta la vita dell’umanità e stata, è e sarà sempre, una continua lotta. Vi sono di quelli che ne sono usciti bene e di quelli che ne sono usciti male. Che ci ho da fare io? Tanto peggio per gli uni e tanto meglio per gli altri. Guai ai vinti! Ecco la gran legge di natura contro cui non c’è rivolta possibile.
Che cosa vorresti tu? Che io mi spogliassi di quel che ho per marcire poi io nella miseria, mentre qualche altro gozzoviglierebbe coi denari miei?
Michele. – Io non voglio precisamente questo. Ma penso: se i lavoratori profittando che sono molti e poggiandosi sulla vostra teoria che la vita è lotta e che il diritto deriva dai fatti, si mettessero in testa di fare un nuovo «fatto storico», quello cioè di levarvi la terra ed il capitale ed inaugurare un diritto nuovo?
Prospero. – Eh! Certo; questo potrebbe imbrogliare un po’ le nostre faccende.
Ma… continueremo un’altra volta. Ora ho da andare a teatro.
Buona sera a tutti.
Capitolo II
Ambrogio (magistrato). – Senta signor Prospero, ora che stiamo fra noi, tutti buoni conservatori. L’altra sera quando parlavate con quel caposcarico di Michele io non volli metterci bocca; ma, vi par modo quello di difendere le istituzioni?
Quasi quasi sembrava te voi l’anarchico!
Prospero. – To! e perché?
Ambrogio. – Perché dicevate, in sostanza, che tutto il presente organamento è fondato sulla forza, danno così ragione a quelli che colla forza vorrebbero distruggerlo. Ma dunque, i supremi principii che reggono le società civili, il diritto, la morale, la religione non li contate per nulla dunque?
Prospero. – Già, voi avete sempre la bocca piena del vostro diritto. È un vizio che vi viene dal mestiere.
E dire che se domani il governo decretasse, supponiamo, il collettivismo, vuoi condannereste i partigiani della proprietà individuale colla stessa impassibilità con cui condannate oggi gli anarchici… e sempre in nome dei supremi principii del diritto eterno ed immutabile!
Vedete bene che è questione di nomi. Voi dite diritto, io dico forza; ma poi quel che conta davvero sono i santi carabinieri, ed ha ragione chi li ha dalla sua.
Ambrogio. – Via, via, signor Prospero! Pare impossibile come in voi l’amor del sofisma debba sempre soffocare gli istinti del conservatore.
Non comprendete di quanto cattivo effetto è il vedere una persona come voi, uno dei maggiorenti del paese, fornire argomenti ai peggiori nemici dell’ordine.
Credete a me: smettiamola questa mala abitudine di bisticciarci tra noi, almeno in pubblico; e stringiamoci tutti in un fascio per difendere le istituzioni che per malvagità dei tempi stanno ricevendo delle brutte scosse… e per difendere i nostri interessi in pericolo.
Prospero. – Stringiamoci pure; ma se non si pigliano delle misure energiche, se non la si smette col dottrinarismo liberale non si riesce a nulla.
Ambrogio. – Oh! sì, questo certamente. Leggi severe ci vogliono e severamente applicate.
Ma non basta. Colla forza soltanto non si tiene a lungo il popolo soggetto, massime coi tempi che corrono. Bisogna opporre propaganda, bisogna persuadere la gente che noi abbiamo ragione.
Prospero. – E state fresco allora! Povero amico mio, per i comuni interessi, ve ne prego, guardatevi bene dalla propaganda. Questa è roba sovversiva anche se fatta da conservatori; e la vostra propaganda tornerebbe sempre a vantaggio dei socialisti, anarchici o come altro diavolo si chiamano.
Andate mo a persuadere qualcuno che ha fame che è giusto che egli non mangi, tanto più poi quando è lui stesso che ha prodotto la roba da mangiare! Fino a che non ci pensa e tira innanzi benedicendo Dio per quel poco che gli lasciano, sta bene. Ma dal momento che comincia a riflettere sulla sua condizione, l’è finita: colui è un nemico che non vi riconciliate più.
Che, che! Bisogna evitarla ad ogni costo la propaganda, soffocare la stampa, con o senza o magari contro la legge…
Ambrogio. – Questo sì, questo sì.
Prospero. – Impedire ogni riunione, sciogliere tutte le associazioni, mandare in carcere tutti quelli che pensano…
Cesare (negoziante). – Piano, piano, non vi lasciate trascinare dalla passione. Ricordatevi che altri governi, ed in tempi più propizii, hanno adottato i mezzi che voi consigliate… ed hanno precipitata la loro caduta.
Ambrogio. – Zitto zitto! ecco Michele che viene con un anarchico che ho condannato l’anno passato a sei mesi di carcere per un manifesto sovversivo. In realtà, sia detto tra noi, il manifesto era fatto in modo che la legge non potesse colpirlo, ma che volete? l’intenzione delittuosa v’era… e poi la società deve essere difesa!
Michele. – Buona sera, signori. Vi presento qui un amico anarchico che ha voluto accettare la sfida lanciata l’altra sera dal signor Prospero.
Prospero. – Ma che sfida, che sfida. Si discorre così tra amici per passare il tempo.
Dunque, voi ci spiegherete che cosa è quest’anarchia di cui non abbiamo mai potuto capir niente.
Giorgio (anarchico). – Io non faccio il professore d’anarchia e non vengo a farsi un corso di anarchia; ma insomma le mie idee posso difenderle. Del resto c’è qui il signore (accennando al presidente Ambrogio in modo ironico) che deve saperla più lunga di me. Ha condannato tanta gente per anarchismo; e siccome è certamente uomo di coscienza, non deve averlo fatto senza avere prima studiato profondamente l’argomento.
Cesare. – Via, via, non facciamo questioni personali. E giacché dobbiamo parlare di anarchia, entriamo subito in argomento.
Vedete, io pure riconosco che le cose vanno male e che bisogna apportarvi dei rimedii. Ma non bisogna fare delle utopie, e sopratutto bisogna fuggire dalla violenza. Certamente il governo dovrebbe più a cuor e la causa de lavoratori; dovrebbe procurar lavoro ai disoccupati; proteggere l’industria nazionale, incoraggiare il commercio. Ma…
Giorgio. – Quanta roba vorreste far fare a quel povero governo! Ma il governo non ne vuole sapere di occuparsi degli interessi dei lavoratori e si capisce.
Cesare. – Come si capisce? Finora veramente il governo si è mostrato incapace, e forse poco voglioso di apportar rimedio ai mali del paese; ma domani dei ministri illuminati e zelanti potrebbero fare quello che non si è fatto finora.
Giorgio. – No, caro signore, non è questione di un ministero o dell’altro. È questione del governo in generale; di tutti i governi, quello di oggi, come quelli di ieri, come quelli di domani. Il governo emana dai proprietarii, ha bisogno per sostenersi dell’appoggio dei proprietarii, i suoi membri sono essi stessi dei proprietarii; come potrebbe dunque fare gli interessi dei lavoratori?
D’altra parte il governo, anche volendo, non potrebbe risolvere la questione sociale perché questa dipende da cause generali, che non possono essere distrutte da un governo e che anzi determinano esse stesse la natura e l’indirizzo del governo. Per risolvere la questione sociale occorre cambiare radicalmente tutto il sistema che il governo ha appunto missione di difendere.
Voi parlate di dar lavoro ai disoccupati. Ma come può fare il governo se lavoro non ce n’è? Deve far fare dei lavori inutili? e chi li paga poi? Dovrebbe far produrre per provvedere ai bisogni insoddisfatti della gente? Ma allora i proprietarii non troverebbero più da vender e i prodotti che usurpano ai lavoratori, anzi dovrebbero cessare di essere proprietarii, poiché il governo per poter far lavorare la gente dovrebbe levar loro la terra e il capitale che essi hanno monopolizzati.
Questo sarebbe la rivoluzione sociale, la liquidazione di tutto il passato, e voi sapete che se non lo fanno i lavoratori, i poveri, i diseredati, certo il governo non lo farà mai.
Proteggere l’industria ed il commercio, voi dite: ma il governo non può, tutto al più, che favorire una classe d’industriale a discapito di un ‘altra, i commercianti di una regione a danno di quelli di un’altra, e quindi, in totale, non ci sarebbe nulla di guadagnato, e solo un po’ di favoritismo, un po’ d’ingiustizia e molte spese improduttive in più. In quanto ad un governo che proteggerebbe tutti è un’idea assurda, poiché il governo non produce nulla e quindi non può che spostare la ricchezza prodotta dagli altri.
Cesare. – Ma allora? Se il governo non vuole e non può far nulla, che rimedio c’è? Anche se fate la rivoluzione bisognerà poi bene che facciate un altro governo; e siccome voi dite che tutti i governi sono lo stesso, dopo la rivoluzione sarà la stessa cosa di prima.
Giorgio. – Voi avreste ragione se la rivoluzione che noi vogliamo fosse un semplice cambiamento di governo. Ma noi vogliamo la completa trasformazione del regime della proprietà, del sistema di produzione e di scambio; ed in quanto al governo, organo parassitario, inutile e dannoso, noi non ne vogliamo affatto. Noi riteniamo che fino a quando vi sarà un governo, cioè un ente sovrapposto alla società e fornito di mezzi per imporre con la forza la propria volontà, non vi sarà reale emancipazione, non vi sarà pace fra gli uomini.
Voi sapete che io sono anarchico, e anarchia vuol dire società senza governo.
Cesare. – Ma come? Una società senza governo! Come si farebbe a vivere? Chi farebbe la legge? Chi la farebbe eseguire?
Giorgio. – Veggo che non avete alcuna idea di quello che noi vogliamo. Per non perdere il tempo in divagazioni bisognerà che mi lasciate spiegarvi, brevemente, ma metodicamente il programma nostro; e così potremmo discutere con utile reciproco.
Ma ora è tardi; incominceremo la prossima volta.
Capitolo III
Cesare. – Dunque ci spiegherete stasera come si può fare a vivere senza governo?
Giorgio. – Farò del mio meglio. Ma prima di tutto esaminiamo un po’ come si sta nella società attuale e se davvero è necessario cambiarne la costituzione.
Osservando la società in cui viviamo, i primi fenomeni che ci colpiscono sono la miseria che affligge le masse, l’incertezza del domani che più o meno pesa su tutti, la lotta accanita che tutti combattono contro tutti per la conquista del pane…
Ambrogio. – Ma, caro signore, voi potreste continuare per un pezzo a descrivere i mali sociali; purtroppo la materia non manca. Ma questo non serve a nulla, e non dimostra che si starebbe meglio mettendo tutto a soqquadro. Non v’è soltanto la miseria che affligge l’umanità; vi sono anche la peste, il colera, il terremoto… e sarebbe curioso che voi voleste fare la rivoluzione contro questi flagelli.
Il male sta nella natura delle cose…
Giorgio. – Ma io voglio appunto dimostrarvi che la miseria dipende dal modo presente di organizzazione sociale, e che in una società più equamente e più ragionevolmente organizzata essa deve sparire. Quando di un male non si conoscono le cause e non si sa come rimediarvi, pazienza; ma appena il rimedio è scoperto, diventa interesse e dovere di tutti l’applicarlo.
Ambrogio. – Qui sta il vostro errore: la miseria dipende da cause superiori alla volontà ed alle leggi umane. La miseria dipende dalla natura avara che dà prodotti insufficienti ai desideri degli uomini.
Vedete fra gli animali, dove non c’è da accusare l’infame capitale né il governo tiranno; essi non fanno altro che lottare per l’alimento e spesso muoiono di fame.
Quando non ce n’è, non ce n’è. La verità è che siam troppi al mondo. Se la gente sapesse con tenersi e non facesse figliuoli se non quando può mantenerli… Avete letto Malthus?
Giorgio. – Sì, un poco; ma se non l’avessi letto sarebbe lo stesso. Quello che io so, senza aver bisogno di leggerlo in nessuna parte, si è che ci vuole una bella faccia tosta, scusate veh! a sostenere di codeste cose.
La miseria dipende dalla natura avara, voi dite, e pur sapete che vi sono tante terre incolte…
Ambrogio. – Ma se vi sono terre incolte vuol dire che sono incoltivabili, che non possono produrre abbastanza per pagare le spese.
Giorgio. – Voi credete?
Provate un po’ a regalarle ai contadini e vedrete che giardini vi faranno. E poi, o che ragionate sul serio? Ma se molte di quelle terre sono state coltivate altra volta e quando l’arte agricola era nell’infanzia e la chimica e la meccanica applicate all’agricoltura non esistevano quasi! Non sapete che oggi si possono trasformare terre ubertose perfino dai sassi? Non sapete che gli agronomi, anche i meno entusiasti, han calcolato che un territorio come l’Italia, se coltivato razionalmente potrebbe mantenere nell’abbondanza una popolazione di cento milioni?
La vera ragione per cui le terre sono la sciate incolte e non si cava da quelle coltivate che una piccola parte di quello che potrebbero dare se si adoperassero metodi di coltura meno primitivi, si è che i proprietari non hanno interesse ad aumentare i prodotti.
Essi non si curano del benessere del popolo; essi fanno produrre per vendere, e sanno che quando c’è molta roba i prezzi ribassano ed il profitto scema e può finire coll’essere, in totale, minore di quello che ricavano ora che i prodotti scarseggiano e possono essere venduti al prezzo che piace a loro.
Né questo avviene solo in fatto di prodotti agricoli. In tutti i rami dell’attività umana è lo stesso. Per esempio: in tutte le città i poveri sono costretti a vivere in tuguri infetti, ammucchiati senza riguardo alcuno all’igiene ed alla morale, in condizioni in cui è impossibile tenersi puliti ed elevarsi ad una vita umana. Perché avviene ciò? Forse perché mancano le case? Ma perché non si costruiscono case sane, comode e belle, a sufficienza per tutti?
Le pietre, la terra da mattoni, la calce, il ferro, il legno, tutti i materiali da costruzione abbondano; abbondano i muratori, i falegnami, gli architetti a spasso, che non domandano di meglio che lavorare; perché dunque si lasciano inattive tante forze che potrebbero essere adoperate a vantaggio di tutti?
La ragione è semplice, ed è che si fossero molte case i fitti ribasserebbero. I proprietarii delle case fatte, che sono poi gli stessi, che avrebbero il mezzo di farne delle altre, non hanno nessuna voglia di veder diminuire le loro rendite per i begli occhi della povera gente.
Cesare. – C’è del giusto in quello che voi dite; ma vi ingannate nello spiegare i fatti dolorosi che affliggono il nostro paese.
La causa della terra male o punto coltivata, dell’arenamento degli affari, della miseria generale è che la nostra borghesia non ha slancio. I capitalisti sono paurosi o ignari, e non vogliono o non sanno sviluppare le industrie, i proprietarii di terre non sanno staccarsi dal come faceva il nonno e non vogliono fastidi, i commercianti non sanno aprirsi nuovi sbocchi e il governo col suo fiscalismo e la sua stupida politica doganale invece di incoraggia re le iniziative private, le inceppa e le soffoca in fasce. Vedete la Francia, l’Inghilterra, la Germania.
Giorgio. – Che la nostra borghesia sia neghittosa ed ignorante non lo metto in dubbio, ma questa sua inferiorità spiega solo il perché essa è battuta dalle borghesie degli altri paesi nella lotta per la conquista del mercato mondiale: non spiega punto il perché della miseria del popolo. E la prova evidente è che la miseria, la mancanza di lavoro e tutto il resto dei mali sociali esistono nei paesi dove la borghesia è più attiva ed intelligente, tanto quanto in Italia: anzi quei mali sono generalmente più intensi nei paesi dove l’industria è più sviluppata, salvo che gli operai non abbiano saputo, con l’organizzazione, conquistare migliori condizioni di vita.
Il capitalismo è lo stesso dappertutto. Esso ha bisogno per vivere e prosperare di una condizione permanente di semi carestia: ne ha bisogno per mantenere i prezzi e ne ha bisogno per trovare sempre degli affamati pronti a lavorare a qualunque condizione.
Vedete infatti che quando in un paese qualunque la produzione è spinta con attività non è mai per dare ai produttori il mezzo per consumare di più, ma sempre per vendere in un mercato fuori. Se il consumo locale aumenta è solo quando gli operai han saputo profittare delle circostanze per esigere di un aumento di salario ed hanno così conquistato la possibilità di comperare più roba. Ma poi, per una ragione o per l’altra il mercato di fuori pel quale si lavora non compra più, la crisi viene, il lavoro s’arresta, i salarii scendono e la miseria nera ricomincia le sue stragi. Eppure, nel paese stesso la grande maggioranza manca di tutto e sarebbe tanto ragionevole lavorare per il proprio consumo! Ma allora i capitalisti che cosa ci guadagnerebbero?
Ambrogio. – Cosicché voi credete che tutta la colpa sia del capitalismo?
Giorgio. – Già; o più generalmente, del fatto che alcuni individui hanno accaparrato la terra e tutti gli strumenti di produzione e possono imporre ai lavoratori la loro volontà, in modo che invece di produrre per soddisfare ai bisogni, si produce per il profitto dei padroni.
Tutte le ragioni che potreste immaginare per salvare i privilegi borghesi sono tanti errori, o tante bugie. Poc’anzi dicevate che la causa della miseri a è la scarsezza dei prodotti. In un altro momento, messo di fronte al problema dei disoccupati, avreste detto che i magazzini sono pieni, che la roba non si può vendere, e che i padroni non possono far lavorare per gettar via la roba.
Ed infatti tale è l’assurdità del sistema: si muore di fame perché i magazzini sono pieni e non v’è bisogno di coltivare, o piuttosto i proprietarii non hanno bisogno di far coltivare le terre; i calzolai non lavorano e quindi vanno colle scarpe rotte perché vi sono troppe scarpe… e così di seguito.
Ambrogio. – Dunque sono i capitalisti che dovrebbero morir di fame?
Giorgio. – Oh! no certamente. Essi dovrebbero semplicemente lavorare come gli altri. Vi sembrerà un po’ duro, ma non credete: quando si mangia bene, il lavoro non è poi il diavolo. Vi potrei anzi dimostrare che è un bisogno ed una gioia dell’organismo umano.
Ma giusto, domani debbo andare a lavorare ed è già troppo tardi. A un’altra volta.
Capitolo IV
Cesare. – Mi piace ragionare con voi. Voi avete un certo modo di porre le cose che sembrano aver ragione… e non dico che abbiate completamente torto.
Delle assurdità, reali o apparenti, ci sono certamente nel presente ordinamento sociale. Per esempio una cosa difficile è comprendere quella della dogana . Mentre qui da noi la gente muore di fame o di pellagra per la mancanza di pane buono ed abbondante, il governo mette difficoltà a ricevere il grano d’ America, dove ne hanno più di quello che occorre e non domandano di meglio che di vendercelo. Sembra come uno che avesse fame e non volesse mangiare!
Però…
Giorgio. – Già, ma il governo non ha fame lui; e non ne hanno nemmeno i proprietarii granisti d’Italia, per l’interesse dei quali il governo mette il dazio sul grano. Se quelli che han fame fossero liberi, voi vedreste lo rifiuterebbero il grano!
Cesare. – Lo so, e comprendo che con questi argomenti voi riusciate a far breccia nel popolino, che vede le cose all’ingrosso e da un lato solo. Ma per non sbagliarsi bisogna guardare tutti i lati della questione, ed io mi accingevo a farlo quando mi avete interrotto.
Sta bene che l’interesse dei proprietarii influisce molto nella imposizione dei dazi d’entrata. Ma d’altra parte, se le frontiere fossero aperte, gli americani che possono produrre il grano e la carne a migliori condizioni di noi finirebbero col fornire completamente tutto il nostro mercato; e allora che cosa farebbero i contadini nostri? I proprietarii sarebbero rovinati, ma i lavoratori starebbero ancora peggio. Il pane avrebbe un bel vendersi anche ad un soldo al chilo, ma se quel soldo non ci fosse modo di guadagnarlo si morirebbe di fame lo stesso. E poi gli americani, o poco o molto, la roba che mandano vogliono che sia pagata, e se in Italia non si producesse con che cosa si pagherebbe?
Potreste dirmi che in Italia si potrebbero coltivare quei prodotti pei quali il suolo ed il clima sono più adatti e scambiarli coi forestieri: il vino, per esempio, gli aranci, i fiori e che so io. Ma se quelle cose che noi possiamo produrre a buon patto gli altri non le vogliono, o perché non ne adoperano, o perché se le fanno da loro? Senza contare che a trasformar le culture ci vogliono capitali, conoscenze e sopratutto tempo: che si mangerebbe intanto?
Giorgio. – Ma perfettamente! voi avete messo il dito sulla piaga. Il libero scambio non può risolvere la questione della miseria più che noi possa fare il protezionismo. Il libero scambio giova ai consumatori e nuoce ai produttori, e viceversa il protezionismo giova ai produttori protetti e nuoce ai consumatori; sicché per i lavoratori che sono nello stesso tempo produttori e consumatori, in definitiva l’è sempre io stesso.
E sarà sempre lo stesso fino a che non si abolisce il sistema capitalistico.
Se i lavoratori lavorassero per conto loro, e non già per dar guadagno ai padroni, allora ogni paese potrebbe produrre a sufficienza per i suoi bisogni, e poi non avrebbe che da mettersi d’accordo cogli altri paesi per distribuirsi il lavoro di produzione secondo le qualità del suolo, il clima, la facilità di avere la materia prima, le disposizioni degli abitanti, ecc.; in modo che tutti gli uomini potessero avere il massimo di godimenti col minimo sforzo possibile.
Cesare. – Sì, ma questi non sono che rosei sogni.
Giorgio. – Saran sogni ora; ma quando il popolo avrà capito che in quel modo si starebbe meglio, il sogno presto si trasformerà in realtà. Di ostacoli non ve ne sono che quelli opposti dall’egoismo degli uni e dall’ignoranza degli altri.
Cesare. – Ce ne sono ben altri di ostacoli, caro mio. Voi immaginate che cacciati via i padroni sguazzereste nell’oro…
Giorgio. – Io non dico questo . Al contrario, io penso che per uscire dallo stato di penuria in cui il capitalismo ci mantiene ed organizzare la produzione in modo da soddisfare largamente ai bisogni di tutti, bisognerà lavorare e molto; ma non è già la voglia di lavorare che manca al popolo, è la possibilità. Noi ci lamentiamo del sistema attuale non tanto perché ci tocca di mantener negli agi degli oziosi – abbenché anche questo ci faccia tutt’altro che piacere – quanto perché sono quegli oziosi che regolano il lavoro e ci impediscono di lavorare in buone condizioni e di produrre in abbondanza e per tutti.
Cesare. – Voi esagerate. È vero che spesso i proprietarii non fanno lavorare per ispeculare sulla scarsezza dei prodotti, ma più spesso è perché essi stessi mancano di capitali.
La terra e le materie prime non bastano per produrre. Ci vogliono, voi lo sapete, gli strumenti, le macchine, i locali, i mezzi per pagare gli operai mentre lavorano, il capitale insomma; e questo non si accumula che lentamente. Quante intraprese restano in progetto, o, incominci ate, falliscono per mancanza di capitali! Figuratevi poi se, come vorreste voi, avvenisse una rivoluzione sociale! Colla distruzione di capitale ed il gran disordine che ne seguirebbe, non raggiungereste che la miseria generale.
Giorgio. – Quest’è un altro errore, o un’altra bugia dei difensori dell’ordine presente: la mancanza di capitale.
Il capitale può mancare a questa o a quella intrapresa a causa dell’accaparramento fatto di altri; ma presa la società in generale, trovate che vi è una grande quantità di capitale inattivo, tale e quale come vi è una gran quantità di terre incolte.
Non vedete quante macchine che irruginiscono, quante fabbriche che restano ferme, quante case che non trovano inquilini?
Ci vuole il nutrimento per gli operai mentre lavorano; ma insomma questi operai debbono mangiare anche se sono disoccupati. Mangiano poco e male, ma restano in vita e pronti a lavorare appena un padrone ha bisogno di loro. Dunque non è perché mancano i mezzi per vivere che gli operai non lavorano; e se essi potessero lavorare per loro conto, si adatterebbero, quando fosse davvero necessario, anche a lavorare vivendo come fanno quando sono disoccupati, poiché saprebbero che con quel sacrifizio temporaneo uscirebbero poi definitivamente dallo stato di miseria e di soggezione.
Figuratevi, ciò che s’è visto molte volte, che un terremoto distrugga una città, rovini un’intera contrada. In poco tempo la città è ricostruita più bella di prima e nella contrada non resta più traccia del disastro. Siccome in tal caso i proprietari ed i capitalisti hanno interesse a far lavorare, i mezzi si trovano subito, e si ricostruisce in un batter d’occhio un’intera città, dove forse prima si era continuato a dire per delle diecine d’anni che non v’erano mezzi per fabbricare qualche «casa operaia».
In quanto poi alla distruzione di capitali che avverrebbe in tempo di rivoluzione, c’è da sperare che in un movimento cosciente fatto collo scopo di mettere in comune le ricchezze sociali, il popolo non vorrà distruggere quella che sta per diventare roba sua. In ogni modo non farà mai peggio di un terremoto!
No: delle difficoltà ce ne saranno di certo prima che le cose si accomodino per bene; ma impedimenti seri, senza vincere i quali non si può incominciare, io non ne veggo che due, l’incoscienza del popolo e… i carabinieri.
Ambrogio. – Ma, dite un po’: voi parlate di capitale, lavoro, produzione, consumo, ecc.; ma di diritto, di giustizia, di morale e di religione non ne parlate mai?
Le questioni sul modo migliore di utilizzare la terra ed il capitale sono molto importanti; ma più importanti ancora, perché fondamentali, sono le questioni morali. Io pure desidererei che tutti stessero bene, ma se per raggiungere questa utopia si dovesse violare la legge morale, se si dovessero rinnegare i principii eterni del di ritto, su cui deve essere fondata ogni civile società, oh! allora preferisco mille volte che continuino per sempre le sofferenze dell’oggi.
E poi, pensate che vi deve es sere pure una volontà suprema che regola il mondo. Il mondo non si è fatto da sé e vi deve essere un al di là – non dico Dio, Paradiso, Inferno perché voi sareste capace di non crederci vi deve essere un al di là che spiega tutto e nel quale devono trovar compenso le apparenti ingiustizie di quaggiù.
Credete voi di poter violare l’armonia prestabilita dell’universo? Voi non potete, noi non possiamo che inchinarci.
Cessate una volta dal sobillare le masse, cessate dal suscitare chimeriche speranze negli animi dei diseredati della fortuna, cessate dal soffiare nel fuoco che purtroppo cova sotto le ceneri. Volete voi, o barbari moderni, distruggere in un terribile cataclisma sociale la civiltà che è gloria dei nostri padri e nostra? Se volete far opera buona, se volete lenire per quanto è possibile le sofferenze dei miseri, dite loro che si rassegnino alla propria sorte, poiché la vera felicità sta nel contentarsi. ché, d’altronde, ognuno porta la sua croce; ogni classe ha i suoi triboli e i suoi doveri, e non sempre i più felici sono quelli che vivono nella ricchezza.
Giorgio. – Via, egregio magistrato, lasciate da parte le declamazioni sui «grandi principii» e le convenzionali indignazioni; qui non stiamo in tribunale, e, pel momento, voi non avete da pronunciare nessuna sentenza contro di me.
Come s’indovina, a sentirvi parlare, che voi non siete tra i diseredati! Ed è tanto utile la rassegnazione dei miseri.., per quelli che vivono sulle loro spalle.
Prima di tutto lasciate, vi prego, gli argomenti trascendentali, religiosi, ai quali non credete nemmeno voi. Dei misteri dell’Universo io non so nulla, e voi non ne sapete di più; ed è perciò inutile tirarli in discussione. Del resto badate che la credenza in un supremo fattore, in un Dio creatore e padre degli uomini non sarebbe poi un’arma sicura per voi. Se i preti, che sono sempre stati e stanno al servizio dei signori, ne deducono il dovere dei poveri di rassegnarsi alla loro sorte, altri ne può dedurre (e si trova nel corso della storia chi ne ha dedotto) il diritto alla giustizia ed all’eguaglianza. Se Dio è il nostro padre comune, noi siamo tutti fratelli. Dio non può voler e che alcuni dei suoi figli sfruttino e martorizzino gli altri; ed i ricchi, i dominatori sarebbero dei Caini maledetti dal Padre.
Ma lasciamo andare.
Ambrogio. – Ebbene, lasciamo pure andare la religione, perché tanto con voi sarebbe inutile.
Ma ammetterete bene un diritto ed una morale, una giustizia superiore!
Giorgio. – Sentite: se fosse vero che il diritto, la giustizia, la morale richiedessero e consacrassero l’oppressione e l’infelicità, sia pure di un solo essere umano, io vi direi subito che diritto, giustizia, morale non sono che menzogne, armi infami forgiate a difesa dei privilegiati; e tali esse sono infatti quando s’intendono come voi l’intendete.
Diritto, giustizia, morale debbono tendere al massimo bene possibile di tutti, o altrimenti sono sinonimi di prepotenza ed ingiustizia. Ed è tanto vero che questo concetto risponde alla necessità dell’esistenza e dello sviluppo del consorzio umano, che esso si è formato e persiste nella coscienza umana e va acquistando sempre più forza, malgrado tutti gli sforzi in contrario di quelli che finora hanno comandato nel mondo. Voi stesso non potreste difendere, altrimenti che con miseri sofismi, le presenti istituzioni sociali coi principii di morale e di giustizia, qual voi li intendete quando parlate in astratto.
Ambrogio. – Voi siete davvero molto presuntuoso. Non vi basta di negare, come mi pare che facciate, il diritto di proprietà; ma pretendete che noi siamo incapaci di difenderlo coi nostri stessi principii…
Giorgio. – Appunto questo. Se vorrete ve lo dimostrerò la prossima volta.
Capitolo V
Giorgio. – Dunque, signor magistrato, se non mi sbaglio, restammo alla questione del diritto di proprietà.
Ambrogio. – Infatti. Ed io sono davvero curioso di sentire come potrete difendere, in nome della giustizia e della morale, i vostri propositi di spogliazione e di rapina.
Una società in cui nessuno fosse sicuro del suo, non sarebbe più una società, ma un’orda di belve sempre pronte a divorarsi l’un l’altra.
Giorgio. – E non vi pare che questo sia proprio il caso della società attuale? Voi ci accusate di volere la spogliazione e la rapina; ma non sono invece i proprietarii che continuamente spogliano i lavoratori e rapiscon loro il frutto del loro lavoro?
Ambrogio. – I proprietari usano della roba loro come meglio credono, ed hanno il diritto di farlo, allo stesso modo che i lavoratori dispongono liberamente delle loro braccia. Padroni ed operai contrattano liberamente il prezzo dell’opera, e quando il contratto non è violato nessuno ha da lagnarsi.
La carità può lenire i dolori troppo acuti, i dolori immeritati, ma il diritto deve rimanere intangibile.
Giorgio. – Ma che mi parlate di libero contratto! L’operaio se non lavora non mangia, e la sua libertà somiglia a quella del viandante, assalito dai ladri, che dà la borsa perché non gli tolgan la vita.
Ambrogio. – Sia pure; ma non per questo voi potete negare il diritto a ciascuno di disporre del suo come gli piace.
Giorgio. – Il suo, il suo! Ma come e perché il proprietario fondiario può dire che la terra è roba sua, ed il capitalista può dire roba sua gli strumenti di lavoro e gli altri capitali creati dall’attività umana?
Ambrogio. – La legge gliene riconosce il diritto.
Giorgio. – Ah! se non è che la legge, allora anche l’assassino di strada potrebbe sostenere il diritto di assassinare e di rubare: non avrebbe che da formulare qualche articolo di legge che gli riconoscesse quel diritto. E d’altronde è precisamente quello che hanno fatto le classi dominanti: o hanno fatto la legge per legittimare le usurpazioni già perpetrate, o l’hanno fatta come un mezzo per usurpazioni novelle.
Se tutti i vostri «supremi principii» sono fondati sui codici, basterà che domani una legge decreti l’abolizione della proprietà privata, equello che oggi voi chiamate rapina e spogliazione diventerà subito un «principio supremo».
Ambrogio. – Oh! ma la legge deve essere giusta! Deve uniformarsi ai principii del diritto e della morale, e non già essere l’effetto del capriccio sfrenato, altrimenti…
Giorgio. – Dunque non è la legge che crea il diritto ma il diritto che giustifica la legge. E allora quale è il diritto per il quale tutta la ricchezza esistente, tanto quella naturale, quanto quella creata dal lavoro dell’uomo appartiene a pochi individui e dà loro il diritto di vita e di morte sulla massa dei diseredati?
Ambrogio. – È il diritto che ha, che deve avere, ogni uomo di disporre liberamente del prodotto della sua attività. È un sentimento natura le dell’uomo, senza del quale non vi sarebbe stato incivilimento possibile.
Giorgio. – To! eccovi ora difensore dei diritti del lavoro. Bravo davvero! ma ditemi, come va allora che coloro che lavorano sono quelli che non hanno nulla, mentre la proprietà appartiene proprio a quelli che non lavorano?
Non vi pare che il risultato logico della vostra teoria sarebbe che gli attuali proprietari sono dei ladri e che, in giustizia, bisognerebbe espropriarli per rendere le ricchezze da essi usurpate ai legittimi proprietarii, i lavoratori?
Ambrogio. – Se vi sono dei proprietari che non lavorano è perché hanno lavorato prima, essi o i loro antenati, ed hanno avuto la virtù di risparmiare e l’ingegno di far fruttare i loro risparmi.
Giorgio. – Già, ve lo figurate voi un lavoratore che, come regola, guadagna appena quanto basta per tenersi in piedi, e che risparmia e mette insieme delle ricchezze!
Voi sapete bene che l’origine vera della proprietà è la violenza, la rapina, il furto legale o illegale. Ma mettiamo pure che uno abbia fatto delle economie sul prodotto del suo lavoro, proprio del lavoro suo personale: se le vuole godere più tardi, quando e come gli pare, sta bene. La cosa però cambia completamente d’aspetto quando incomincia quello che voi chiamate far fruttare i risparmi. Questo significa far lavorare gli altri e rubar loro una parte del prodotto del loro lavoro; significa accaparrare delle merci e venderle più caro di quello che costano; significa creare artificialmente la carestia per specularvi su; significa levare agli altri i mezzi di vivere lavorando liberamente per costringerli poi a lavorare per un meschino salario; e tante altre cose simili, che non corrispondono più al sentimento di giustizia e che dimostrano che la proprietà, quando non deriva dalla rapina franca ed aperta, deriva dal lavoro degli altri, che i proprietarii hanno, con un mezzo o con un altro, rivolto a proprio vantaggio.
Vi pare giusto a voi che un uomo, il quale ha, concediamolo pure, col suo lavoro e col suo ingegno messo insieme un po’ di capitale, possa poi per questo derubare gli altri dei prodotti del lavoro loro, e di più legare a tutte le generazioni dei suoi discendenti il diritto di vivere in ozio sulle spalle dei lavoratori?
Vi pare giusto che, perché vi sono stati pochi uomini laboriosi ed economi – dico così per abbondare nel senso vostro – che hanno accumulato del capitale, la gran massa dell’umanità debba esser condannata in perpetuo alla miseria ed all’abbrutimento?
E d’altronde, quand’anche uno avesse lavorato, proprio lui, coi suoi muscoli e col suo cervello senza sfruttare nessuno; quand’anche, contro ogni concepibile possibilità, uno avesse potuto produrre molto più di quello che gli occorre senza il concorso diretto o indiretto di tutta la società, egli non potrebbe per questo essere autorizzato a fare del male agli altri, a levare agli altri i mezzi di vita. Se uno facesse una strada lungo la riva non potrebbe per questo avanzare il diritto d’impedire agli altri di accedere al mare. Se uno potesse dissodare e coltivare da sè tutto il suolo di una provincia, non potrebbe per questo pretendere di affamare tutti gli abitanti della provincia. Se uno avesse creato dei nuovi e possenti mezzi di produzione, non avrebbe il diritto di usare della sua invenzione in modo da sottoporre gli uomini al suo dominio e ancora meno quello di legare a tutta la serie infinita dei suoi discendenti il diritto di dominare e sfruttare le generazioni future.
Ma che mi perdo io nel supporre anche per un momento che i proprietarii sieno lavoratori o discendenti di lavoratori! Volete che ve la racconti io l’ origine della ricchezza di tutti i signori del nostro comune, tanto dei nobili di antico ceppo, quanto dei commendatori arricchiti da ieri?
Ambrogio. – No, no, per carità, lasciamo andare le questioni personali.
Se vi sono delle ricchezze male acquista te non è una ragione per negare il diritto di proprietà. Il passato è passato, e non giova andare a rivangare le magagne.
Giorgio. – Non rivanghiamo nulla se così vi piace. Per me la cosa non ha importanza. La proprietà individuale va abolita, non tanto perché essa può essere stata più o meno male acquistata, quanto perché essa dà il diritto ed il mezzo di sfruttare il lavoro altrui, e sviluppandosi finisce sempre col mettere la gran massa degli uomini alla dipendenza di pochi.
Ma, a proposito, come fate voi a giustificare la proprietà individuale della terra colla vostra teoria del risparmio? Questa non c’è modo di dire che sia stata prodotta dal lavoro dei proprietarii o dei loro antenati!
Ambrogio. – Ecco. La terra incolta, sterile non ha valore. L’uomo l’occupa, la bonifica, la rende fruttifera, e naturalmente ha diritto ai frutti, che senza l’opera sua la terra non avrebbe prodotti.
Giorgio. – E va bene: questo è il diritto del lavoratore ai frutti del suo lavoro; ma questo diritto cessa quando egli cessa di coltivare la terra. Non vi pare?
Ora, come va che i proprietarii attuali posseggono territori, spesso immensi, che essi non lavorano, che non hanno mai lavorato e spesso non fanno nemmeno lavorare dagli altri? Come va che appartengono a privati anche delle terre che non sono state mai messe in cultura? Qual è il lavoro, qual è il miglioramento che può aver dato origine, in tal caso, al diritto di proprietà?
La verità è che per la terra, come e più che per il resto, l’origine della proprietà è la violenza. E voi non riuscirete a giustificarla, se non accettando il principio che il diritto è la forza, nel qual caso… guai se un giorno sarete i più deboli.
Ambrogio. – Ma insomma, voi perdete di vista l’utilità sociale, le necessità inerenti al consorzio civile. Senza il diritto di proprietà non vi sarebbe sicurezza, non più lavoro ordinato: e la società si dissolverebbe nel caos.
Giorgio. – Come! ora parlate di utilità sociale? Ma se nelle nostre prime conversazioni io non mi occupavo che dei danni che la proprietà privata produce, e voi mi richiamaste alle ragioni del diritto astratto!
Basta per stasera. Scusatemi perché debbo andar via. Ne riparleremo.
Capitolo VI
Giorgio. – Ebbene, avete visto che cosa è successo? Qualcuno comunicò ad un giornale la conversazione che avemmo la volta passata, e, per averla pubblicata, quel giornale è stato imbavagliato.
Ambrogio. – Ah!
Giorgio. – Già, voi non ne sapete nulla, s’intende… Io non capisco come potete pretendere di avere ragione quando avete tanta paura che il pubblico senta un po’ discutere sulle vostre idee. In quel giornale v’erano riportati fedelmente gli argomenti vostri ed i miei. Voi dovreste essere contento che il pubblico possa apprezzare le basi razionali su cui poggia la presente costituzione sociale, e far giustizia delle vane critiche dei suoi avversari. Invece voi chiudete la bocca alla gente, imbavagliate.
Ambrogio. – Ma io non c’entro per nulla; io appartengo alla magistratura giudicante e non al pubblico ministero.
Giorgio. – Si, sta bene! ma poi siete sempre colleghi e lo stesso spirito vi anima tutti.
Se le mie chiacchiere vi annoiano ditemelo… ed io andrò a farle altrove.
Ambrogio. – No, no, al contrario. Vi confesso che ci ho preso interesse. Continuiamo pure; e in quanto al sequestro dirò io una buona parola al Procuratore del re. Dopo tutto, colla legge quale è, il diritto di discutere nessuno ve lo può negare.
Giorgio. – Continuiamo dunque. L’altra volta, se mi ricordo bene, nel difendere il diritto di proprietà voi pigliavate a base ora la legge positiva, cioè il codice, ora il sentimento di giustizia, quindi l’utilità sociale. Permettete che io vi ricapitoli in poche parole le mie idee in proposito.
Secondo me la proprietà individuale è ingiusta ed immorale perché fondata o sulla violenza aperta, o sulla frode, o sullo sfruttamento legale del lavoro altrui; ed è dannosa perché inceppa la produzione ed impedisce che dalla terra e dal lavoro si ricavi tutto quello che occorre per soddisfare i bisogni di tutti gli uomini, perché crea la miseri a delle masse e genera l’odio, i delitti e la più gran parte dei mali che affliggono la società moderna.
Per ciò la vorrei abolita per sostituirvi un regime di proprietà comune, in cui tutti gli uomini, dando il loro giusto contributo di lavoro, ricavassero il massimo benessere possibile.
Ambrogio. – Ma veramente io non veggo con quale logica voi arriviate alla proprietà comune. Voi avete combattuta la proprietà perché, secondo voi, deriva dalla violenza e dallo sfruttamento del lavoro altrui; avete detto che i capitalisti regolano la produzione in vista del loro profitto e non già per soddisfare il meglio che si può i bisogni del pubblico col minore sforzo possibile dei lavoratori; voi avete negato il diritto di ricavare una rendita da una terra che non si coltiva colle proprie mani, di dare a frutto il proprio danaro o di cavarne un interesse impiegandolo nella costruzione di case ed in altre industrie; ma però il diritto del lavoratore al prodotto del proprio lavoro voi lo avete riconosciuto, anzi ve ne siete fatto paladino. Per conseguenza, in logica stretta, voi potete reclamare la verifica dei titoli di proprietà fatta secondo i vostri criterii, l’abolizione dell’interesse del danaro e della rendita; potete magari domandare la liquidazione della società presente e la divisione delle terre e degli strumenti di lavoro fra coloro che vogliono servirsene.., ma non potete parlare di comunismo. La proprietà individuale dei prodotti del lavoro personale dovrà sempre esistere; e, se volete che il vostro lavoratore emancipato abbia quella sicurezza del domani senza cui non si fa alcun lavoro che non dia un frutto immediato, dovete anche riconoscere la proprietà individuale della terra e degli strumenti di produzione che uno adopera, almeno fino a quando li adopera.
Giorgio. – Da bravo, continuate pure; si direbbe che siete intinto anche voi di pece socialista. L’è una scuola socialista diversa dalla mia, ma infine l’è sempre socialismo. Un magistrato socialista è un fenomeno interessante.
Ambrogio. – No, no, niente socialista. Io facevo solo per prendervi in contraddizione e mostrarvi che logicamente dovreste essere non un comunista ma uno spartitore, un partigiano della divisione dei beni.
Ed allora vi direi che il frazionamento della proprietà renderebbe impossibile ogni grande intrapresa e produrrebbe la miseria generale.
Giorgio. – Ma io non sono uno spartitore, un partigiano della divisione dei beni, né lo è ch’io sappia nessun socialista moderno.
Io non credo che dividere i beni sarebbe peggio che lasciarli uniti nelle mani dei capitalisti; ma so che essa divisione, quando fosse possibile, sarebbe di grave danno alla produzione. Di più essa non potrebbe durare e menerebbe di nuovo alla costituzione delle grosse fortune, alla proletarizzazione delle masse ed alla miseria e lo sfruttamento ad oltranza.
Io dico che il lavoratore ha diritto al prodotto integrale del suo lavoro: ma riconosco che questo diritto non è che una formula di giustizia astratta; e significa, in pratica, che non vi debbono essere sfruttatori, che tutti debbono lavorare e godere dei frutti del lavoro, secondo i modi che tra di loro converranno.
Il lavoratore non è un essere isolato nel mondo, che vive da sé e per sé, ma un essere sociale che vive in uno scambio continuo di servigi cogli altri lavoratori, e deve coordinare i diritti suoi coi diritti di tutti gli altri. Del resto è impossibile, massime coi metodi moderni di produzione, il determinare in un prodotto quanta sia la parte esatta di lavoro che ciascun lavoratore ha fornito, come è impossibile il determinare, nella differenza di produttività di ciascun operaio o di ciascun gruppo di operai, quanta parte sia dovuta alla differenza di abilità e di energia spiegata dai lavoratori e quanta dipenda dalla differenza di fertilità del suolo, di qualità degli strumenti adoperati, di vantaggi o difficoltà dipendenti dalla situazione topografica o dall’ambiente sociale. E quindi la soluzione non può trovarsi nel rispetto del diritto stretto di ciascuno, ma deve ricercarsi nell’accordo fraterno, nella solidarietà.
Ambrogio. – Ma allora non v’è più libertà.
Giorgio. – Invece è allora soltanto che vi sarà libertà. Voi, cosidetti liberali, chiamate libertà il diritto teorico, astratto, di fare una cosa; e sareste capaci di dire senza ridere, né arrossire, di un uomo che è morto di fame per non aver potuto procurarsi il vitto, ch’egli era libero di mangiare. Noi invece chiamiamo libertà la possibilità di fare una cosa – e questa libertà, che è la sola vera, diventa tanto più grande quanto più cresce l’accordo tra gli uomini e l’appoggio che si danno l’un l’altro.
Ambrogio. – Voi avete detto che se si dividessero i beni, presto le grandi fortune si ricostituirebbero e si ritornerebbe allo stato di prima. Perché questo?
Giorgio. – Perché sarebbe fin dal principio impossibile mettere tutti in istato di perfetta uguaglianza. Le terre differiscono grandemente tra loro, le une producendo molto con poco lavoro e le altre poco con molto lavoro; grandi sono i vantaggi o gli svantaggi di ogni specie che offrono le diverse località, e grandi pure le differenze di forza fisica ed intellettuale tra uomo ed uomo . Ora, fin dal momento della divisione sorgerebbe naturalmente la rivalità e la lotta: le migliori terre, i migliori siti, i migliori strumenti andrebbero agli uomini più forti, o più intelligenti o più furbi. Quindi, trovandosi i migliori mezzi materiali nelle mani degli uomini meglio dotati, questi si troverebbero subito in posizione molto superiore agli altri, e partendo da questi vantaggi primitivi, facilmente crescerebbero in forza, riprincipiando così un nuovo processo di sfruttamento ed espropriazione dei deboli, che metterebbe capo alla ricostituzione della società borghese.
Ambrogio. – Ma questo si potrebbe impedire con delle buone leggi, che dichiarassero inalienabili le quote individuali e circondassero i deboli di serie garanzie legali.
Giorgio. – Uff! voi credete sempre che si possa rimediare a tutto con delle leggi. Non siete magistrato per nulla! Le leggi si fanno e si disfanno a piacere dei forti.
Quelli che sono un poco più forti della media, le violano; quelli che sono molto più forti le abrogano, e ne fanno altre secondo l’interesse loro.
Ambrogio. – E allora?
Giorgio. – Allora, ve l’ho già detto, bisogna sostituire alla lotta tra gli uomini l’accordo e la solidarietà, e per questo bisogna innanzi tutto abolire la proprietà individuale.
Ambrogio. – Dunque, proprio sul serio, voi siete comunista? Tutto è di tutti, lavora chi vuole e chi non vuole fa all’amore; mangiare, bere, scialare! O che cuccagna! o che bella vita! o che bella gabbia di matti! Ah! ah! ah!
Giorgio. – Per la figura che fate volendo difendere con dei ragionamenti questa società che solo si regge colla forza brutale, non mi pare davvero che abbiate tanto da ridere!
Sissignore, io son comunista. Ma voi sembrate avere delle strane nozioni sul comunismo. La prossima volta cercherò di farvi capire. Per ora, buona sera.