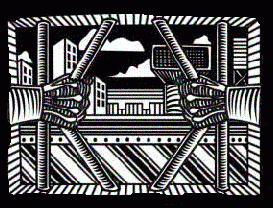Questo testo è la trascrizione della conferenza dal titolo omonimo tenuta da Massimo Passamani a Rovereto il 5 dicembre 2000.
In solidarietà ai compagni di Rovereto e Trento indagati, perquisiti ed arrestati nel corso dell’operazione repressiva denominata Ioxididae (ovvero zecca in latino!), posta in essere dalla Digos di Trento, su mandato della Procura di Trento, lo scorso 27 agosto.
Il carcere e il suo mondo
Riflessioni per una società senza gabbie
Qualche parola prima di entrare nell’argomento di questa sera: il carcere e il suo mondo. Innanzitutto, non sarà una riflessione di taglio storico, su quelle che sono le cause storiche del carcere, perché su questo argomento ci sono già molti libri che fanno ormai addirittura parte della normalità accademica; ci sono fior fior di tesi di laurea sul carcere, tanti testi che dimostrano il legame stretto che esiste fra la nascita e lo sviluppo del capitalismo e la nascita e la trasformazione del carcere, quindi il rapporto tra fabbrica, clinica, prigione e così via. Testi più o meno approfonditi che esistono in quantità abbondanti, talvolta piuttosto interessanti e rispetto ai quali non avrei molto da aggiungere. Quindi non è un taglio di quel tipo che mi interessa: chi si aspetta una conferenza di questo tipo penso che rimarrà deluso. E anche sul rapporto tra il carcere e la società di oggi, cioè su tutto quel sistema sociale che ruota attorno alle prigioni, anche su questo la riflessione sarà piuttosto sbrigativa, non sarà un approfondimento specifico. Quello che mi interessa, invece, è una riflessione di tipo etico, intendendo per etica un modo di essere, un modo di abitare e un modo di autodeterminarsi, cioè di scegliere gli strumenti e le finalità dei propri rapporti. Quindi un concetto di etica che assume in sé le due accezioni del termine, cioè l’etica come dimensione individuale (quell’insieme di valutazioni che ogni individuo dà circa le proprie scelte, il senso della sua vita, dei suoi rapporti, eccetera) e anche una dimensione per così dire collettiva, cioè relativa a quello spazio in cui queste scelte, queste valutazioni, questi rapporti si realizzano, si modificano. Due accezioni che coesistono nelle parole stesse che utilizziamo per esprimere questi concetti. Sia etica sia morale, infatti, rinviano a un concetto di costume, di norme sociali, di genius loci, cioè di usi legati a una determinata zona; allo stesso tempo, e sempre di più nell’ultimo secolo, il concetto di etica rinvia a qualcosa di profondamente individuale, di singolare e attinente all’unicità di ogni individuo. Questi aspetti saranno, penso, copresenti all’interno di queste riflessioni. Riflessioni piuttosto rapide, perché l’inventario delle questioni, dei problemi è molto ampio e io non ho nessuna pretesa di esaurire gli argomenti.
Quattro punti su cui riflettere, niente di più. La domanda fondamentale, quella che tutti i vari libri eludono sempre, lasciano ai margini oppure tendono a confondere in modo più o meno efficace, questa domanda radicale suona così: se il carcere significa punizione, castigo, pena, evidentemente fa riferimento alla trasgressione di una determinata regola (infatti la punizione interviene nel momento in cui la regola viene trasgredita, violata). Ora, la trasgressione della regola rinvia a sua volta al concetto stesso di regola, e cioè a chi decide – e come – le regole di una società. Questa è la questione che i vari operatori del settore, gli esperti non affrontano mai. Questa è la questione che contiene tutte le altre e che se sviluppata fino in fondo rischia di far crollare tutto l’edificio sociale e con esso le sue prigioni. Chi decide, e come, le regole di questa società? È palese che tutte le chiacchiere che vengono raccontate sul potere del cittadino (“il cittadino, questa cosa pubblica che ha soppiantato l’uomo”, diceva Darien), sulla partecipazione diretta, si rivelano sempre di più per quello che in sostanza sono, cioè menzogne. A decidere in questa società e in tutte le società basate sullo Stato, sulla divisione in classi, sulla proprietà, è una ristretta minoranza di individui i quali si autonominano rappresentanti del “popolo” e che impongono, sulla base di determinati poteri esecutivi (coercitivi), le loro regole. Questa definizione piuttosto generica fa subito notare che regola e legge, accordo e legge, non sono sinonimi. La legge non è una regola come le altre, è un modo particolare di concepire e definire la regola: la legge è una regola autoritaria, è una regola coercitiva, imposta per di più da una ristretta minoranza. Ora, è possibile concepire un modo completamente diverso per definire le regole, oppure, detto diversamente, per prendere degli accordi. Quindi, se non c’è coincidenza fra accordo e legge, la questione radicale è: come può un individuo o un insieme di individui essere punito in base a regole coercitive, quindi leggi, che non ha mai sottoscritto, che non ha mai liberamente accettato, che non ha mai stabilito? Anche questa è una domanda estremamente semplice, ma che non viene mai posta.
Ancora prima di porsi l’interrogativo di cosa significa concepire i rapporti fra individui in termini di punizione, castigo, pena; ancora prima di porsi questa domanda, bisogna chiedersi se è legittimo, giusto, utile, piacevole che un individuo, un insieme di individui, siano repressi, puniti, rinchiusi, torturati per la trasgressione di norme che non hanno mai concepito né sottoscritto. È questa la questione fondamentale a cui si tratta di trovare risposta, una risposta che è sì teorica, ma che deve farsi poi spazio nella pratica. Ora, evidentemente, nel modo stesso in cui pongo il problema in controluce si può notare come io penso di affrontarlo.
Il libero accordo è la possibilità e la capacità che vari individui, più o meno numerosi nel loro associarsi, hanno di stabilire in comune determinate regole per realizzare le loro attività, attività di cui controllano le finalità e gli strumenti. Senza questo controllo delle finalità e degli strumenti del proprio agire non esiste nessuna autonomia, che è appunto la capacità di darsi le proprie regole. Esiste allora il dominio, l’essere diretti da altri, quindi lo sfruttamento. Proprio perché questa società non si fonda sul libero accordo, quest’ultimo si sviluppa solamente all’interno di piccoli gruppi dove esiste la consapevolezza della possibilità di avere rapporti di reciprocità, di libertà, quindi senza forme coercitive; ma al di là di piccoli gruppi che, in modo conflittuale rispetto alla società, cercano di vivere in questo modo, all’interno di questo ordine delle cose non esiste una simile possibilità, perché appunto viviamo in una società fondata sulla divisione in classi, sul dominio e sullo Stato che di questa divisione in classi e di questo dominio è in qualche modo il prodotto e il garante. Allora si capirà perché questa società ha come suo centro la prigione, si capirà perché e per chi esiste questa prigione. Ed è proprio partendo da questa riflessione che si può cogliere il problema della punizione, quindi il problema del diritto e, ancor più nel concreto, di quel codice penale su cui i giudici fondano le loro sentenze che chiudono a chiave uomini e donne in ogni parte del mondo, su cui i poliziotti trovano l’autorità per arrestare, i secondini per sorvegliare, l’assistente sociale del carcere per invitare alla calma e alla collaborazione, il prete per trovare materia funzionale alle sue prediche sul sacrificio, sulla rinuncia, sulla colpa (tanto per citare alcuni di coloro che garantiscono questo sistema sociale). Partendo da questa riflessione ci si può rendere conto che all’interno della presente società il carcere è un problema ineliminabile, perché il problema del crimine, cioè della trasgressione delle norme coercitive (le leggi) è un problema fondamentalmente sociale. Per dirla diversamente: finché esisteranno i ricchi e i poveri, esisterà il furto; finché esisterà il denaro, non ce ne sarà mai abbastanza per tutti; finché esisterà il potere, nasceranno sempre i suoi fuorilegge. Quindi, rovesciando la questione, il carcere è una soluzione statale a problemi statali, è una soluzione capitalista a problemi capitalisti. Il problema del furto, cosi come di tutti quei crimini che tendono alla messa in discussione dell’ordine sociale, quindi le rivolte, le resistenze, le lotte insurrezionali, eccetera, ecco tutti questi problemi sono legati alle radici stesse di questa società. È evidente che siamo ancora nell’ambito delle domande. Le risposte possono venire soltanto da una pratica sociale di cui è possibile delineare solo e soltanto alcune prospettive. Proprio perché parlare di questi problemi cosi impostati non ci permette di uscire da quel quadro sociale al cui interno soltanto essi hanno un senso.
La storia del carcere si lega profondamente alla storia del capitalismo e dello Stato, e quest’ultima si lega profondamente a tutte le resistenze, a tutte le lotte, le insurrezioni e le rivoluzioni da parte degli sfruttati, degli spossessati di tutto il mondo per sbarazzarsi -talvolta con slanci di libertà reale e talaltre con ritorni a repressioni ancora peggiori, ancora più brutali -, per sbarazzarsi del capitalismo, del denaro, della proprietà, della divisione in classi, dello Stato. Negli ultimi due secoli, perché sostanzialmente l’origine del carcere per come lo conosciamo noi non va più indietro nella storia (non che prima non esistesse il problema dell’esclusione, del bando dalla società, o addirittura della tortura e dell’eliminazione fisica, però il luogo concreto, spazialmente definito che è il carcere non esisteva) il problema delle prigioni è stato presente in tutti i movimenti di emancipazione, di trasformazione radicale della società. È sempre stato presente nelle riflessioni e anche negli argomenti di propaganda, i quali si potevano riassumere in questo modo: se distinguiamo due tipi di crimine, (si trattava di una distinzione per amore di chiarezza, perché in realtà il contesto sociale e le sue trasformazioni sono sempre molto più complessi, molto più articolati e quindi molto più difficili da catalogare), quelli che potremmo definire di interesse, cioè legati al denaro, alla necessità all’interno di questa società di avere denaro per sopravvivere, e quelli passionali. Ora, è evidente -argomentavano questi rivoluzionari – che i primi, cioè quelli di interesse, sono profondamente legati a questa società: per cui o si immagina un mondo in cui non ci sono alcuni che accaparrano gli strumenti, le ricchezze e tutto quello che è necessario per vivere e gli altri che, spinti dal bisogno, sono costretti o a prostituirsi come lavoratori salariati o ad allungare le mani per afferrare illegalmente (dato che la legge sta dalla parte dei proprietari) le ricchezze, oppure non ci sarà mai soluzione. Per quanto riguarda invece i crimini cosiddetti passionali, che poi sono quelli più sventolati dalla propaganda dominante per giustificare il carcere: anche quelli, come gli stupri, che più offendono la coscienza di ciascuno; anche questi crimini, se noi li guardiamo più attentamente, sono profondamente legati alla società in cui viviamo, nel senso che sono il prodotto della miseria affettiva, compresa quella sessuale, dell’assenza di rapporti appaganti nella vita quotidiana, della miseria di rapporti umani in generale; sono il prodotto di tutta quella tensione, di quello stress, di quella rabbia che non vengono espressi e che ritornano, proprio come un ospite indesiderato, sotto forma di tic nervosi, sotto forma di presenza inconscia, di violenza stupida e gregaria. Anche questi fenomeni – che sono poi quelli utilizzati sempre per rendere necessario, nella mente di tutti gli sfruttati, il carcere con tutta la sua struttura sociale, che vengono utilizzati come spauracchio per far accettare la presenza dell’autorità e dell’ordine poliziesco – sono dunque profondamente legati a questa società. Negli argomenti di quei vecchi compagni, una società senza Stato e senza denaro, materialmente e passionalmente ricca, avrebbe eliminato d’ufficio i cosiddetti crimini di interesse e ridotto sempre più i cosiddetti crimini passionali. E noi?
È evidente che il concetto di trasgressione, di violazione delle norme rinvia a tutto quel pensiero filosofico, morale, giuridico, politico e così via che si è costruito all’interno di questa società e che per difendere questa società si è sviluppato, articolato, definito. Parlare di carcere, insomma, non significa soltanto parlare della regola e quindi porsi la domanda radicale che tutti eludono: chi la stabilisce, in base a quali criteri, che cosa fare per affrontare un problema come quello della sua trasgressione. Oltre a questo, bisogna chiedersi anche cosa significa proiettare un modello di convivenza, di umanità rispetto al quale poter giudicare non ortodosso, bollare in quanto ortopedicamente deviante o moralmente inaccettabile ogni comportamento, ogni scelta, ogni decisione che non si rifaccia, che non si assoggetti a quel modello. Ho usato il concetto di “ortopedia” sia perché è un concetto preciso nella riflessione dei vari criminologi, dei vari esperti in devianze, sia perché anche etimologicamente è un concetto interessante. La necessità di far camminare rettamente (questo significa “ortopedia”) rispetto ai percorsi che sono stati stabiliti dalla società, di costringere alle sue strade, alle sue mete e ai suoi ostacoli tutti gli individui, è la fonte inesauribile di tutte le gabbie. Problema della regola, dunque, problema del modello che viene ritenuto superiore agli individui concreti, che è anche un modo, questo, di crearsi recinti nella testa, per rassicurarsi di fronte all’aspetto multiforme e quindi pauroso della vita sociale. Questo modello agisce, ad esempio, nel momento in cui determinati comportamenti, che offendono profondamente il senso di umanità di ciascuno, vengono definiti inumani: basta pensare che in tedesco inumano e mostro si esprimono con la stessa parola (Unmensch). Tutto quello che è mostruoso viene definito inumano per tenerlo lontano da sé; determinati atti, determinati comportamenti sono bollati come inumani, oppure – e questo è il versante penale, giuridico – criminali.
All’interno di questa società il carcere non va visto come qualcosa di occasionale soltanto perché, in fondo, parlando della situazione italiana, su 55 milioni di abitanti i carcerati sono circa 50 mila, una cifra, questa, che potrebbe sembrare irrisoria rispetto a quello che sto dicendo. In realtà, il carcere è un dato centrale, fondamentale di questa società; esso è presente in tutta la società e non va confuso soltanto con quegli edifici che fisicamente rinchiudono determinati uomini e determinate donne. Perché è un perno fondamentale di questa società? Proprio perché la repressione di cui il carcere è l’espressione più radicale non va vista come qualcosa di distinto dal consenso forzato, da quella pace sociale su cui si fonda l’ordine presente delle cose, intendendo per pace sociale non la convivenza pacifica delle persone, ma la convivenza pacifica tra sfruttatori e sfruttati, tra dominatori e dominati, tra dirigenti ed esecutori. Ecco, la pace sociale è questa condizione che viene prodotta da organi ben precisi come la magistratura e la polizia, ma allo stesso tempo da tutte quelle istituzioni – siano esse il lavoro, la famiglia, la scuola, il sistema dei mezzi di comunicazione di massa, eccetera – che rendono impossibile o estremamente difficile ogni pensiero critico e quindi ogni volontà di trasformare radicalmente la propria vita; in breve, quella trama di rapporti, di parole e di immagini che presenta l’attuale ordine delle cose non come un prodotto storico, e dunque, come tutti i prodotti storici, modificabile, ma come un dato naturale che nessuno ha la possibilità né il diritto di mettere in discussione. Quindi, se noi vediamo il carcere (e, più in generale, la repressione di cui il carcere è il modello) come il prolungamento di quelle norme sociali che quotidianamente ci impongono una sopravvivenza sempre più priva di senso, allora vediamo che il carcere è uno spettro che viene agitato contro gli irrequieti che potrebbero in un determinato momento della loro vita decidere di farla finita con questo modo di sopravvivere, con questo modo di stare legati in società, e battersi per conquistare una libertà, una dignità differenti. Questo spettro viene continuamente agitato contro gli occhi capaci di sguardi ulteriori, di slanci oltre le gabbie sociali.
Purtroppo – ed è questo il paradosso della società in cui viviamo – questi occhi sono pochi, perché già questo desiderio di ribellarsi è uno sforzo, uno slancio che si conquista a fatica, perché a vincere, spesso, non è neanche la paura del castigo, paura che tocca solo quelli che per un motivo o per l’altro si pongono concretamente il problema di trasgredire le regole in un modo che non conviene a questa società, per tutti gli altri basta quel ricatto continuo e incessante che è il vivere civile, il vivere sociale con tutti i suoi obblighi e le sue prestazioni. Ancora prima di questa paura della punizione, cioè, la repressione preventiva è l’incapacità di immaginare una vita diversa: non avendo un’alternativa – non come modello sociale, ma come progetto di vita, di modificazione dell’esistente -; non avendo questa alternativa nella testa, non rimane che accettare questo mondo. Infatti attualmente la propaganda dominante, per farci accettare questa società, non usa quasi più gli argomenti dell’ordine giusto, accettato in base ai sacrosanti principi della proprietà, del diritto, della morale (la loro, evidentemente), ma dice più semplicemente e senza fronzoli: non esiste nient’altro. Quindi, visto che questo altro non esiste, perché o è già finito nella spazzatura della storia o è impraticabile, allora non rimane che rassegnarsi e accettare questa società. Questa condizione più che essere una condizione di consenso, intendendo per consenso un’assentire consapevole, diretto e libero a determinate situazioni, a determinati accordi, è quella di un consenso per difetto, cioè di un non-dissenso: si vive in questa società semplicemente perché non si riesce a immaginare e a praticare qualcosa di diverso. (E questo ci lega nuovamente al discorso iniziale sulla differenza tra libero accordo – condizione di reciprocità – e legge – condizione di gerarchia). Tutto quello che questa società spaccia per Progresso,per meta da raggiungere, è sempre più manifestamente impresentabile, perché i disastri prodotti da questo modo di vita (sotto forma di oppressioni, di affamamento, di catastrofi mascherate come naturali ma in realtà profondamente sociali) sono sotto gli occhi di tutti. Il potere stesso, questa megamacchina in cui la politica, l’economia, la burocrazia, il comando militare si confondono, punta oggi su un discorso catastrofista: il mondo va verso disastri consistenti, però, visto che siamo noi ad averli creati – ci dicono i suoi esperti pagati per esserlo -, siamo anche i soli a possedere le chiavi per risolverli. Cosi, all’interno di questo balletto immobile fra disastri sociali e finti rimedi, a loro volta portatori di futuri disastri, l’immaginazione viene congelata, colonizzata; nessuna alternativa è possibile e quindi tutto procede per consenso in negativo, per non-dissenso. Però evidentemente non tutti sono d’accordo con queste regole.
Se prendiamo alla lettera l’ideologia dominante, quella liberale, ci viene detto che il vivere sociale è il risultato di un contratto stipulato non si sa bene quando né da chi, comunque da generazioni passate, rispetto al quale le generazioni presenti non possono far altro che adeguarsi: già questo è piuttosto indicativo del modo di concepire gli accordi, stabiliti una volta non si sa bene da chi e che poi dovrebbero legare (la legge, appunto) per il resto del tempo tutte le generazioni future dell’umanità. Comunque queste scempiaggini sono state raccontate anche da filosofi piuttosto accreditati e quindi si dice, questo si impersonale che è tutti e nessuno, che questa società è il frutto di un contratto. Ora, è evidente che quando esistono milioni di individui (perché bisogna sempre ragionare con un occhio attento al pianeta e alla storia, dal momento che il potere vuole spingerci a ragionare in un eterno presente che non ha nessun riferimento con il passato e soprattutto ci chiude gli occhi su come funziona il modello democratico su scala planetaria) a cui si nega persino il minimo vitale, questo contratto sociale è una presa in giro assassina. Quando si parla di democrazia, non bisogna tener presente solo la televisione, gli acquisti di natale, le nuove auto e le conseguenze che tutto ciò comporta a livello sociale e anche psicologico; bisogna tener presente anche i campi di lavoro forzato in Indocina, l’affamamento delle popolazioni del sud del mondo, le guerre sparse sul pianeta, perché tutto ciò è solo la periferia delle nostre cittadelle democratiche. Lo stesso ordine capitalista democratico che assicura a determinati sudditi, in vista di un determinato sviluppo politico, economico, burocratico, un certo modo di vivere, ad altri impone di marcire nelle riserve, nei ghetti. Se ci poniamo il problema di prendere alla lettera quest’ideologia del contratto sociale -di cui le varie teorie ortopediche sono il semplice corollario – è evidente allora che per chi non ha di che vivere, per chi non è nemmeno considerato cittadino, perché non ha i documenti in regola, perché non lo fanno entrare alle frontiere, per chi è costretto in una condizione di clandestinità, di invisibilità sociale, per donne e uomini come questi (e oggi sono milioni) il presunto contratto è stato violato per sempre, dal momento che non garantisce nemmeno i mezzi di sussistenza. Ora, persino filosofi tutt’altro che libertari, tutt’altro che partigiani dell’emancipazione individuale e sociale, sostenevano che quando un contratto viene violato unilateralmente, chi ne subisce gli effetti ha tutto il diritto di andarsi a prendere quei beni, quelle ricchezze, quelle condizioni che gli sono stati sottratti; se non ha nessun accesso a questo mondo della proprietà è necessario e giusto che quel mondo lo attacchi allungando le mani sulle ricchezze, cioè rubando. All’interno di questa società, anche se numericamente il problema sembra poco consistente, perché sono in pochi tutto sommato ad essere rinchiusi, il ricatto del carcere pesa su milioni di individui. La sopravvivenza si fa sempre più precaria, basta pensare alle ragioni concrete per cui la maggior parte di quelli che finiscono in carcere sono processati e poi condannati e rinchiusi; si tratta, per la stragrande maggioranza, di piccoli reati, furti, traffici che un ordinamento legislativo diverso potrebbe domani considerare come non reati, e quindi cancellare in un sol tratto tutto quello che per decenni è stato considerato crimine. E questo alla faccia dell’universalità dei principi che dovrebbero valere in ogni luogo e in ogni epoca. Le ragioni sociali del crimine sono talmente evidenti, che i riformatori dello Stato devono far finta di metterci mano.
Ci sono stati diversi professori universitari, persone per bene, generalmente di sinistra e con ottime intenzioni pedagogiche, che hanno cominciato a parlare di abolizione del carcere all’interno di questa società. Il carcere così com’è, in fondo, alle anime pie di sinistra non piace, perché rinchiudere a chiave uomini e donne per lo più poveri è una cosa sgradevole e degradante, tanto che questi bei personaggi sono i primi a dire che la funzione rieducatrice della punizione è una manifesta menzogna, perché il carcere non ha mai rieducato chicchessia; al contrario -aggiungono – è una palestra del crimine: quelli che vi sono entrati perché non potevano o non volevano lavorare non fanno altro che organizzare meglio le loro attività criminali del futuro. Per tutti questi illuminati, quindi, il carcere è qualche cosa di spiacevole, è qualcosa che andrebbe modificato e se possibile cancellato da questa società. Evidentemente, questi professori si rendono conto che, in una società fondata su regole coercitive decise da una minoranza che domina il resto della popolazione, il problema del castigo non ha soluzione. Se il carcere potesse essere abolito, sarebbe solo per essere sostituito con altre forme più sociali, meno legate a un’istituzione totale (identificata in un edificio ben preciso, con funzionari ben precisi, eccetera), come i braccialetti elettronici alle gambe, queste catene pressoché invisibili capaci di creare una nuova figura: il detenuto sociale. Tutto ciò non fa di certo aprire il carcere né porta meno carcere nella società; semplicemente, fa diventare la società sempre più simile a un carcere. Vanno in tal senso anche le proposte di riappacificazione tra le vittime di determinati furti e i loro autori. Ad esempio, i metodi proposti nella democrazia scandinava, piuttosto progredita dal punto di vista di queste forme pulite di punizione sociale, sono del tipo: se mi hai rubato lo stereo, invece di mandarti in carcere -ospitalità forzata e forzosa che tra l’altro sono io a pagare in quanto contribuente -, mi metto d’accordo con il tuo giudice e magari una volta al mese vieni e mi rifai la facciata del palazzo, mi dai una mano a tagliare le aiuole. Queste proposte, ideate da chi è pagato dallo Stato per trovare soluzioni a quelli che sono problemi creati dallo Stato, nascondono un fatto: all’interno di questa società, il problema del carcere può essere semplicemente spostato, cioè si può trasformare sempre di più la società in un immenso carcere in un ergastolo sociale, ma non distrutto.
Esiste una differenza profonda fra la prospettiva di abolire il carcere all’interno di questa società, cosa che significherebbe rafforzare il dominio dando una vernice di rispettabilità a un ordine sociale profondamente autoritario, e quella di distruggerlo – il che significa: distruggere tutte le condizioni sociali che lo rendono necessario. Questa è una cosa completamente diversa. Paradossalmente, la sola prospettiva non utopica non è quella di pensare che possa esistere il denaro senza il furto, il potere senza le rivolte, la colonizzazione senza la resistenza; è quella di sovvertire alla radice le condizioni che rendono tutto ciò necessario, sopprimere le classi e abbattere ogni Stato.
L’ultimo punto a cui vorrei accennare, lasciandolo aperto per la discussione, è questo: cosa significa battersi ora per una società senza carcere, quindi non soltanto per distruggere le prigioni e il mondo che le costruisce, ma anche per non costruirne mai più? Significa ripensare in modo radicale non soltanto il problema della regola e dell’accordo, ma anche il problema di come far fronte alla risoluzione dei conflitti che in ogni contesto sociale – con buona pace di tutti i propagandisti socialisti e anche anarchici del passato – si verificherebbero. Se questa società, con il grado di putrescenza che ha raggiunto, non ci lascia certo essere ottimisti sulle sorti di una trasformazione radicale del mondo, ci pone il problema di come affrontare diversamente il conflitto: non più con la mentalità ortopedica (non sei d’accordo con determinate regole, non vado a rivedere le regole stesse, visto che le abbiamo stabilite di comune accordo, dico semplicemente che sei nemico di un modello, modello universalmente accettato e quindi un’altra volta coercitivo, e se non ti metto in carcere, ti metto in qualche manicomio, ti considero pazzo, ti faccio curare dalla scienza che ti rimetterà a posto). Queste soluzioni sono altrettanto autoritarie e forse ancora più totalitarie, perché se il carcere almeno considera il criminale cosciente e risoluto nella sua identità di criminale, marchiare invece chi trasgredisce le regole di questa società mostruosa come un malato che ha bisogno di cure significa non soltanto metterlo nelle mani di specialisti che lo tortureranno magari scientificamente e senza che si veda il sangue, ma significa anche considerarlo incapace di determinare per sé cos’è il giusto e lo sbagliato. Cosa significa battersi quindi per un mondo senza sbarre, cosa significa quindi distruggere il carcere, questa cosa abominevole che è chiudere a chiave degli uomini e delle donne, per non costruirne mai più? E cosa significa legare questa prospettiva di distruzione del carcere, in quanto distruzione della repressione, della pace sociale, del Diritto, alle lotte attualmente esistenti nelle carceri? Che cosa vuoI dire, in questa prospettiva di distruzione del carcere, essere solidali con chi, attualmente detenuto, si batte evidentemente non per distruggere tutte le prigioni (perché questa sarà sempre il desiderio di una minoranza), ma per attenuarne gli aspetti repressivi? Cosi come non esistono molti individui all’interno della società a voler cambiare radicalmente le regole del gioco, non si vede perché, per il semplice fatto di essere tali, i detenuti dovrebbero raggiungere chissà quale consapevolezza per cambiare le sorti proprie e altrui. E qui il problema si allarga di nuovo: le prigioni non sono nient’altro che il concentrato di questa società, dei suoi spazi, dei suoi tempi, del suo lavoro, delle sue concezioni urbanistiche (basta pensare a tutti quegli edifici che, nell’arco di mezzo secolo, sono stati via via manicomi, scuole elementari, carceri, ospedali senza che si modificasse in nulla la loro struttura, cosa che la dice lunga sul mondo in cui viviamo …). Il carcere è ovunque, basta guardarsi attorno: telecamere di sorveglianza ad ogni angolo, esattamente come quelle che ci sono nelle carceri, controllo informatico sempre più incessante, sempre più capillare nella sua penetrazione sociale, senza dimenticare le sempre attuali divise di carabinieri e polizia, come quelle qua fuori stasera. All’interno di questo mondo che è sempre più simile a una prigione, cosa significa immaginare addirittura una società senza gabbie e cosa significa, in quanto detenuti sociali, essere solidali con altri che sono detenuti in senso stretto? Questi si battono per dei miglioramenti parziali, così come nel resto della società le lotte partono quasi sempre su basi rivendicative di miglioramenti limitati. Ciò che fa la differenza, sono i rapporti che nascono nel corso stesso della lotta, e i metodi che si usano. Per il resto, la banalità delle loro cause immediate, diceva il filosofo, sono sempre state il biglietto da visita delle insurrezioni nella storia.
Attaccando i mille nodi che fanno funzionare il carcere e il suo mondo, noi stessi abbattiamo sempre più le mura di quel carcere personale che è la rassegnazione.
Solo alcuni buoni interrogativi, come vedete, in un’epoca in cui abbondano le false risposte.
Massimo Passamani
5 dicembre 2000