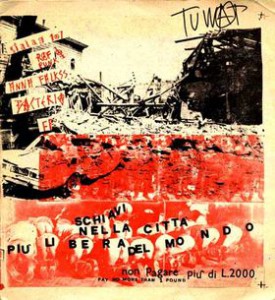Elementi di lotta insurrezionale contro il militarismo e la repressione
Guerra e pace
Le commemorazioni degli avvenimenti del 1914-18 organizzate un po’ dovunque in Europa ci ricordano che tutti sono contro la guerra. Dall’uomo di Stato al cittadino, dall’imprenditore al filosofo, dal ricercatore all’operaio, tutti si dichiarano categoricamente oppositori ad una ripetizione della grande carneficina. Loro sono per la pace. E in nome della stessa pace accettano — a differenti livelli di responsabilità, di collaborazione o di accettazione — alcune guerre. Per ristabilire la stabilità in una regione preda della guerra civile, per soccorrere una popolazione minacciata di genocidio, per sostituire i regimi crudeli: il cammino della guerra è lastricato di buone intenzioni. Nel nome di valori riconosciuti dall’umanità intera — «giustizia» e «pace» — vengono perpetrati i peggiori massacri.
Oggi siamo ben lontani dall’epoca in cui gli Stati si consegnavano reciprocamente dichiarazioni di guerra nelle rispettive ambasciate poco prima di scatenare le ostilità apertamente. Col sostegno di una formula giuridica — figlia del pensiero liberale — come la dichiarazione di guerra, gli Stati fornivano un alibi legale per legittimare ciò che era considerato vietato in «tempo di pace», quali l’omicidio, l’aggressione, lo stupro. Per rendere la guerra compatibile con l’idea del regime liberale, gli Stati dovevano disporre di una formula per sospendere la Costituzione e la legalità.
Nella situazione odierna non è più la legalità ad essere sospesa, né la guerra ha cessato d’esistere, anzi è la guerra a rientrare nella legalità. La guerra viene sempre prima, pur agghindata con diversi termini indicanti magari differenti intensità di terrore statale, ma corrispondenti a una medesima logica militare: operazioni umanitarie (occupazione di un territorio), attacchi aerei (bombardamenti), detenzione di terroristi (rapimenti), eliminazione della minaccia (esecuzioni sommarie).
In quanto anarchici, tutto ciò non ci sorprende più di tanto. Guerra e pace sono due differenti parole che da sempre coprono la continuità dello sfruttamento e del dominio. Il massacro, il sangue e la violenza, la militarizzazione, la disciplina e l’obbedienza, restano centrali per ogni autorità. La questione che forse dovremmo porci è: cos’è diventata la pace? Le operazioni militari scatenate dai paesi democratici che si susseguono a ritmo incalzante, non suscitano più molte contestazioni. E dubitiamo fortemente che ciò sia dovuto al fatto che la popolazione si sia bevuta le giustificazioni sempre più truffaldine dei governi. No, è un’altra la conclusione da fare: la guerra e la pace non sono più vissute come momenti separati.
Qualcuno potrebbe accusarci di un massimalismo un po’ indigesto, ma noi non riusciamo ad accettare la tesi che distingue i luoghi e i tempi di guerra da quelli di pace. D’altronde ciò che sta alla base dell’antimilitarismo anarchico è questo: contro la guerra, contro la pace, per la rivoluzione sociale.
La prima ragione per non operare tale distinzione è che la guerra viene sempre preparata, in quanto ha bisogno di armi, di esercitazioni, di provviste, di pianificazione, di preparazione mentale della popolazione… La preparazione alla guerra è già guerra, e siccome ogni Stato si prepara di continuo alla guerra, non c’è in realtà né guerra né pace.
La seconda ragione è che non sarebbe logico né conseguente, da un lato denunciare la connessione dell’economia con la guerra — il complesso industrial-militare — e dall’altro non considerare macchine da guerra la stessa economia e lo stesso Stato,. Eppure, perfino in base ad orribili statistiche, non è detto che il “normale” funzionamento del capitalismo e del potere non faccia altrettante vittime di una guerra classicamente definita. Capitale e Stato si fondano sul sangue e sul massacro. Tutto ciò che viene prodotto è fondato sul sangue e sul massacro. Ogni iniziativa ed ogni misura dello Stato comportano il massacro, fino al presunto “divertimento”, e il genocidio sociale perpetrato per e durante la Coppa del Mondo in Brasile ne è l’esempio più recente. La pace dei mercati non è altro che la guerra degli sfruttatori contro gli sfruttati, con tutti i mezzi immaginabili.
La terza ragione è che accettare che uno Stato possa decretare la differenza tra guerra e pace, significa in qualche modo riconoscere che ci siano sì guerre inaccettabili, ma anche interventi militari giustificati. La «pace» si mantiene attraverso la paura che il potere riesce a infondere, la guerra viene accettata per paura di un massacro ancora più vasto. Quindi, in ogni momento, il terrorismo di Stato è all’opera.
Ma perché insistere allora sulla guerra, se essa è sempre presente e se è tutt’uno con gli altri aspetti del dominio? Perché paventare oggi l’ipotesi di una imminente ulteriore militarizzazione nella gestione del capitale?
Ristrutturazione, rivolte e guerra
La ristrutturazione in corso a livello economico, politico, sociale e culturale mostra ormai sempre più che un nuovo progetto del dominio sta nascendo, installandosi progressivamente dopo la formalizzazione dell’atto di morte del progetto socialdemocratico e la chiusura di un decennio di tentativi volti ad aggiornarlo sotto forma di «partecipazione cittadina» e di «società civile». Un’analisi dei contorni di tale progetto s’impone nei tempi a venire, per cercare di individuare meglio i cambiamenti sul terreno dello scontro rivoluzionario. E questa analisi non potrà accontentarsi di gettare un semplice sguardo sulla cosa, di procedere ad una elaborazione teorica, ma dovrà anche alimentarsi di nuove esperienze di lotta, pur minoritarie e limitate, e di tentativi per ricomporre una progettualità rivoluzionaria.
Ogni ristrutturazione comporta una certa instabilità. È un po’ come aprire il cofano di un’automobile. D’un tratto il motore compare, tangibile, violento, sporco. Ma gli ingegneri del capitale saranno pur costretti ad aprire quel cofano se intendono cambiare alcuni o tutti i pezzi del motore. Il loro progetto è un nuovo modo di massimizzare la forza esplosiva del carburante, dello sfruttamento, e di assicurarsi che i condotti riescano a gestire la pressione, controllandola.
Erano prevedibili le sommosse che sono scoppiate negli ultimi anni? Qualcuno poteva predire che i moti in Tunisia sarebbero diventati un gigantesco incendio toccando decine di paesi, dall’Egitto alla Siria, dalla Bosnia all’Ucraina? Non lo pensiamo. Neppure il rivoluzionario più ottimista, quand’anche sempre prigioniero della realtà, avrebbe potuto immaginarlo nel 2011. Non lo si poteva immaginare nemmeno dopo la rivolta del dicembre 2008 in Grecia. Alcune teste calde hanno magari tentato di trasformare le loro intuizioni in parole, ma alla fine il contagio insurrezionale si è diffuso più in fretta delle ipotesi dei rivoluzionari. Ed ora, siamo diventati più capaci di riconoscere i focolai insurrezionali, di riconoscerli e di avere un progetto, anche minimo, per contribuire alla loro estensione prima che lo spettacolo chiuda nuovamente il sipario o che lo slancio sia soffocato in un bagno di sangue?
Quel che è certo, è che queste sommosse sono avvenute in un dato contesto, un contesto di ristrutturazione di vari aspetti del dominio, su scala planetaria. Esse hanno mostrato un’anteprima di ciò che potrebbe accadere. La rinascita del desiderio di libertà. La comparsa di pratiche rivoluzionarie e autorganizzate. L’intervento sempre più sanguinoso, sempre più reazionario, di forze religiose e nazionaliste in seno alle rivolte. La guerra civile e il massacro industriale degli insorti. L’auto-affermazione sanguinaria degli Stati, della loro superiorità e imprescindibilità. L’accelerazione dello sfruttamento capitalista. Per dare solo alcuni elementi che abbiamo visto emergere durante e dopo quelle sommosse.
I recenti interventi militari in Libia (bombardamenti della NATO), in Egitto (presa di potere dell’esercito, dopo quella dei Fratelli Musulmani, per schiacciare la rivoluzione), in Siria (la spietata reazione del regime di Assad, le ingerenze militari di altri paesi, i bombardamenti della coalizione, tutti miranti a trasformare la rivoluzione nascente in guerra civile e in «guerra per procura»), in Ucraina (la rivolta popolare affossata da uno scontro tra Stati) e nella striscia di Gaza («per tagliare l’erba che è spuntata», come diceva un parlamentare israeliano, che si può interpretare non solo in relazione alla potenza di Hamas, ma anche al potenziale di rivolta nei territori palestinesi), sono stati probabilmente ispirati e inculcati da sinistri interessi geopolitici. Ma vogliamo anche sottolineare ciò che oggi non ci sembra siano in molti a dire: queste operazioni militari hanno soffocato — di fatto e al di là dell’insieme delle loro “ragioni” complesse e contraddittorie — le rivolte e le sommosse in un bagno di sangue, per incoraggiare la loro trasformazione in guerre etniche e settoriali. Schiacciando così lo slancio e l’immaginario rivoluzionario che aveva saputo catturare il cuore di tanti ribelli e sfruttati negli ultimi anni. Certo, un immaginario nient’affatto chiaro o netto. Non è il fulgido sole dell’avvenire anarchico che trafigge infine le nuvole della menzogna e dell’ideologia. È un immaginario attraversato da mille contraddizioni, fra libertà e reazione, fra sovversione e politica, ma che si è affermato comunque, che ha saputo infondere un po’ di vita alla rivolta degli oppressi, che hanno avuto il coraggio di insorgere contro l’esistente.
Rivoluzionari scettici e partigiani democratici si sono ritrovati nella comune volontà di classificare tali sollevamenti come «grida a favore della democrazia». Gli uni per spiegare o giustificare la propria incapacità di mettere in piedi una solidarietà rivoluzionaria e adoperarsi per l’estensione delle sommosse elaborando un progetto insurrezionale. Gli altri per far rientrare l’insurrezione nella gogna statale e proteggere la continuità dello sfruttamento capitalista. Oggi, riguardando i fatti, più che un recupero democratico è soprattutto la repressione ad aver avuto la meglio. Chi parla ancora di «rivoluzione democratica in Egitto» o di «rivolta democratica contro il regime di Gheddafi»? Chi? Possiamo allora concludere che era quanto meno prematuro, quindi errato, pensare che quei sollevamenti avrebbero subito la stessa sorte della maggior parte delle lotte nell’ultimo decennio se fossero avvenuti sul suolo europeo: il recupero e l’integrazione nello spettacolo. Oggi, assai più della figura dell’abile politico democratico, è il volto bruto della bomba sganciata da un aereo militare, il massacro settario e la detenzione di massa che hanno appena risposto ai desideri rivoluzionari.
Lo slancio di quelle sommosse non è morto. Non ancora. Continua a dar vita a lotte, a volte promettenti, a volte tragiche, in un contesto dove il dominio cerca proprio di trovare le basi per un nuovo equilibrio e disegna i tratti del suo nuovo progetto per continuare ad opprimere e sfruttare. Restare oggi sulla difensiva, significa firmare la condanna a morte di queste rivolte e, ancor peggio, contribuire all’ennesimo affossamento dei desideri di liberazione. Di fronte all’accentuazione della repressione, non è la corsa verso le alleanze con forze autoritarie che dobbiamo intraprendere, ma imboccare una strada che porti a sviluppare un progetto insurrezionale. È con l’insurrezione e le azioni insurrezionali che pensiamo sia possibile spezzare questa spirale che si muove sempre più in fretta verso l’affermazione sanguinaria della supremazia del potere. Sì, il tempo stringe, è già tardi, molto tardi. Ma cerchiamo prima di esaminare anche altri aspetti della realtà nei quali e contro cui il progetto insurrezionale dovrà realizzare il proprio cammino.
Il progetto repressivo:
massacro, militarismo, reclusione
Gli «assalti rivoluzionari» degli anni 70 sono oggi lontani. Le trasformazioni operate dal dominio per neutralizzarli, a parte la repressione massiccia, si possono riassumere per lo più in due tendenze: verso l’inclusione e verso l’esclusione. Questo processo ha tracciato nuove linee di demarcazione in seno alla società. Oggi possiamo constatare quanto tale processo non sia più embrionale, essendosi realizzato come modo di gestione. La sorte riservata agli esclusi è un destino di abbrutimento, di reclusione e di sfruttamento selvaggio in base alla loro collocazione nel pianeta e in funzione dei bisogni della produzione e della riproduzione. Mentre le tecnologie hanno consentito al potere di assicurarsi il controllo capillare dell’insieme della società, il numero dei conflitti armati — in generale sotto forma di guerra civile con l’intervento di altre potenze — non è mai stato così elevato.
I modi di gestione che prima erano riservati soprattutto a situazioni di occupazione militare, come la schedatura, la detenzione amministrativa, la logica concentrazionaria o il controllo dei movimenti, oggi vengono applicati in sempre più ambiti della vita sociale. Tale gestione deriva dall’intreccio di tutte le tecniche di controllo e di governo in una strategia controinsurrezionale di stampo militare. Le lezioni della sperimentazione di un enorme campo di concentramento a cielo aperto nella striscia di Gaza, per esempio, servono sia alle operazioni di sanguinosa pacificazione nelle favela di Rio de Janeiro che alle direttive dell’urbanesimo totalitario nelle metropoli europee.
La militarizzazione delle frontiere dell’Unione Europea, dove muoiono ogni anno migliaia di persone, comporta la militarizzazione di un numero crescente di linee di trasporto all’interno dell’Unione. I modelli di ripristino del controllo nei territori colpiti da un disastro si basano direttamente sulle esperienze in materia di occupazione militare.
Il potere è quindi ben consapevole del fatto che l’esclusione massiccia comporta anche un rischio di esplosioni sociali. Attraverso il processo di distruzione del linguaggio, nel senso di distruzione di ogni immaginario che non sia la realtà del capitale, pensa di riuscire a garantirsi che le eventuali rivolte restino circoscritte per l’appunto ad esplosioni, magari distruttive, ma prive di pulsione rivoluzionaria. In questo quadro, assistiamo alla generalizzazione della logica dell’intervento militare contro qualsiasi rivolta. Sarebbe erroneo interpretare l’accelerazione securitaria, il numero crescente di ricerche e realizzazioni controinsurrezionali, la crescente brutalità nel mantenimento dell’ordine, la recrudescenza a livello giuridico, come segnali che il potere avrebbe paura. Non è che qualche dubbio non possa mai intaccare l’arroganza dei potenti, ma ci sembra che tutto ciò sia destinato piuttosto a fare paura agli esclusi. Seminare la paura è, come ben sappiamo, un modo ottimale per assicurarsi una cieca adesione e una rassegnata sottomissione. E la paura è un ingrediente imprescindibile della guerra.
Oggi tutto può costituire una minaccia, tutto va bene per instillare la paura. Terrorismo, catastrofi ecologiche, penuria energetica, crisi finanziarie… tutti intercambiabili nella gestione sempre più militarizzata della «pace» sociale, ovvero della guerra contro gli sfruttati e gli esclusi.
Se vediamo delinearsi chiaramente dei legami tra la ristrutturazione da un lato, e rivolte, guerra ed esclusione dall’altro, senza contare la paura e la militarizzazione del territorio, anche altri aspetti del dominio sono in corso di ristrutturazione. L’estensione del controllo fisico e mentale, che ingloba oggi la quasi totalità della società e dello spazio sociale, non è sfociata — contrariamente alle intenzioni umanitarie che il potere ha fatto baluginare per un lasso di tempo — in una diminuzione del numero di strutture repressive, bensì in una loro moltiplicazione.
Il potere non ha chiuso delle carceri dopo aver generalizzato il controllo, ma ha esteso la logica carceraria a più ambiti della società, rendendo il confine tra «fuori» e «dentro» sempre più evanescente. Ed oggi, decine di nuove prigioni e di centri per migranti sono in costruzione dovunque in Europa. I regimi speciali — il carcere all’interno delle carceri — si moltiplicano come corollari indispensabili alla gestione della sempre più vasta popolazione prigioniera. Allo stesso modo si potenzia l’arsenale giuridico contro il “banditismo” e il “terrorismo”.
L’ipotesi di un potere pluralista sempre più aperto e tollerante, garante del cammino radioso del capitale, sembra proprio allontanarsi a vantaggio di ben altra ipotesi, quella di una crescente militarizzazione a tutti i livelli.
La fabbrica della repressione
La guerra e i massacri sono centrali per lo sfruttamento capitalista e l’oppressione statale. L’intento di questa affermazione non è di evocare una qualche simpatia o impegno per un umanitarismo benevolo e ingenuo, ma di segnare la distanza con chi è perennemente alla ricerca di «ragioni oggettive» per giustificare davanti al tribunale della storia il loro eventuale (non) intervento rivoluzionario. Il dominio produce continuamente «ragioni oggettive» per non agire, per non far nulla, per accettare — esso produce «pace sociale». Mistifica il fatto che il suo regno si basa sul massacro e sull’orrore. Infrangere questa mistificazione del momento non è un vano gioco retorico, è il primo ostacolo da superare per gettare le basi di un intervento rivoluzionario in ogni momento. Un ostacolo che è anche profondamente morale. Consiste in una montagna di argomenti pacificatori, di sublimazioni dell’orrore provato davanti alla violenza e al sangue. Scalare questa montagna non è compito facile. Perché, in fondo, per passare all’attacco occorre anche spezzare i nostri piccoli cuori addomesticati da secoli di morale e scuotere le nostre braccia disarmate da tanto adattamento. Senza questo, nessun progetto rivoluzionario anarchico sarà possibile.
Ma passiamo ora all’oggetto primario di questo capitolo: La fabbrica della repressione. Tante volte ricercato, tante volte eluso. Se non si concretizzasse in strutture e uomini, la repressione non sarebbe che una vana idea senza influenza reale. E in effetti, non appena si comincia a parlare di produzione bellica, di sistemi di difesa e di sicurezza, di sorveglianza e di controllo, vediamo scorrere immediatamente davanti ai nostri occhi centinaia di officine, di fabbriche e di laboratori, oltre a migliaia di ingegneri, di specialisti, di ricercatori, e anche di operai di base, tutti coinvolti nella produzione di strumenti di morte e di controllo. Le guerre e la militarizzazione sono prodotte qui. Vengono preparate e progettate qui. Esse apportano lucrosi profitti, nella maggioranza dei casi, qui. Ed è perciò anche qui che chi vuole agire può prendere di mira la produzione della guerra.
Così come la linea di demarcazione tra applicazioni «militari» e «civili» è diventata alquanto imprecisa, per non dire inesistente, la produzione di morte comprende sempre più direttamente vasti settori economici. Al di là dei grossi produttori di armi più noti, centinaia di altre imprese, spesso anonime e discrete, forniscono elementi indispensabili alle prime e, una volta assemblati, questi elementi diventano terribili ordigni perfezionati. Lo stesso dicasi per i laboratori e la ricerca. Per dare solo un esempio: la logica concentrazionaria, ovvero il mantenimento dell’ordine territoriale, per divisione in zone (che vediamo all’opera in ogni occupazione militare di un territorio, ma anche nell’urbanizzazione totalitaria delle metropoli) richiede un crescente controllo e una permanente sorveglianza dei confini delle zone e delle loro vie di accesso. Esiste tutta una «scienza» applicata, in vertiginoso sviluppo in questi ultimi anni, in relazione a quella che potremmo definire la problematica del «check point». La ricerca tecnologica per equipaggiare questi check point, reali o “virtuali”, è fra le più avanzate, dovendo realizzare un controllo totale e immediato. I programmi creati per i check point israeliani fortificano altrettanto bene gli accessi agli aeroporti, alle istituzioni, ai trasporti pubblici, alle fabbriche chimiche, ecc.
Oltre che alla ricerca e alla produzione propriamente dette, ci si può anche interessare alla produzione di “umani”, l’addestramento di assassini e di torturatori. Se il processo classico della fabbricazione del perfetto soldato è conosciuto (addestramento, inculcamento di cieca disciplina e poi inserimento nel combattimento, il primo assassinio che apre la porta all’omicidio a ripetizione e su comando), vediamo oggi come questoinserimento possa anche avvenire in modo separato dalla realtà. Il pilota d’aviazione militare non vede il suo obiettivo, vede solo delle coordinate satellitari. Il pilota del drone che assassina in Medio Oriente fa il suo lavoro dalle 9 alle 17, da un parcheggio di caravan situati da qualche parte negli Usa, manovrando una cloche simile a quella di una Playstation. I guardiacoste che sorvegliano le acque del Mediterraneo, assistono via satellite all’annegamento di centinaia di persone la cui imbarcazione di fortuna cola a picco. Più aumenta la distanza emozionale e fisica tra il torturatore e l’oggetto della sua tortura, una distanza coperta sia da un’autorità superiore che da una protesi tecnologica, più il torturatore può fare il proprio lavoro in maniera “efficiente”.
La stragrande maggioranza dei ricercatori che generano i più terribili strumenti di morte, o gli ingegneri che fanno funzionare le fabbriche belliche, sono persone ordinarie da ogni punto di vista. Non si tratta di mostri sanguinari, ed è pure probabile che inorridirebbero davanti all’abbattimento di un bovino. Possono persino essere di sinistra. Se pensassimo di costruire un immaginario rassicurante del nemico sanguinario e reazionario per poterlo attaccare senza esitazione, faremmo un grosso sbaglio e, soprattutto, ci ritroveremmo disarmati davanti alla fabbrica della repressione. Ci vuol ben altro che la produzione di un’immagine «diabolica» del nemico, abbiamo bisogno di idee e desideri che determinino il perché del nostro agire rivoluzionario. Ci occorre l’etica di chi si batte per la sua liberazione, l’etica dell’insorto che non divenga morale tributata alla pacificazione. Ci servono analisi approfondite e informazioni precise.
Contorni di una progettualità anarchica contro la guerra e contro la repressione
Gli anarchici sono contro la guerra, contro tutte le guerre. Ma sono anche contro la pace. Siamo contro la pace dei mercati, contro la pace dell’autorità, contro la pace dell’abbrutimento e della servitù. Siamo per la rivoluzione sociale, per il rovesciamento violento e profondo dei rapporti sociali esistenti, basati sullo sfruttamento e sull’autorità.
Ma queste rocce dell’ideale anarchico non reggono sempre altrettanto bene durante le tempeste. Non era raro sentire qualche compagno affermare che l’intervento della NATO in Libia non era la cosa più conveniente da denunciare. Così come ben poche voci anarchiche si alzano oggi contro l’intervento militare della coalizione internazionale in Siria. Non è neanche raro vedere anarchici soccombere sotto il principio dell’opportunismo tattico «il nemico del mio nemico è mio amico». È ancora utile ricordare che il nemico del mio nemico oggi è stato ieri anche il mio e domani potrei essere considerato nemico io da entrambi gli altri…?
Queste famose rocce tendono anche a erodersi nel fuoco dell’azione, se questa non è sostenuta da una ferma progettualità. Il fascino per la presunta «efficacia» del modello autoritario di guerriglia, per esempio, ha indotto più di un compagno ad accettare di rinunciare — ovviamente sempre «temporaneamente» — a certe basi dell’anarchismo, o a rifiutare la proposta dell’organizzazione informale insurrezionale, giudicata «meno efficace» per scatenare o intervenire nelle ostilità. Eppure, è proprio quest’ultima che potrebbe oggi rivelarsi il miglior modo per combattere la ristrutturazione repressiva in corso, il massacro degli insorti e l’affossamento dello slancio rivoluzionario.
Contro la guerra, ma non disarmati
Può darsi che, come qualcuno ha affermato laconicamente, «siamo diventati deboli». Aggiungendo, «tutti, senza eccezione». Se questo giudizio era rivolto alle capacità teoriche degli anarchici, riguardava ancor più le loro capacità operative.
Questa debolezza diventa ancora più tangibile quando ci si staglia davanti il mostro del massacro e della guerra. Ma non serve a nulla ululare con i lupi: occorre prendere atto di tale debolezza e cercare di porvi rimedio. Senza illudersi di poter fare rapidamente grandi passi, e senza cadere nel culto della «forza» che spinge il più delle volte verso la militarizzazione della lotta, dobbiamo immaginare nuovamente un cammino, un percorso. Ci sono cose che non si imparano all’improvviso; e se il bisogno pressante e immediato può dare una buona spinta, è meglio essersi preparati prima.
È anche una questione mentale. In realtà, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, o quasi, e la vera questione sta nel sapere se siamo pronti a fare gli sforzi necessari e indispensabili. Per dotarsi di conoscenze tecniche, bisogna studiare seriamente le relative materie. Per sviluppare certe capacità, occorre disporre di tempo per dedicarcisi. Solo così queste conoscenze potranno essere utili in un progetto, armando la creatività e rafforzando le idee.
Dobbiamo quindi lavorare in tal senso, se non vogliamo ritrovarci dipendenti da altre correnti, preda dei capricci e delle sole possibilità del momento, o più semplicemente rinunciare ad intervenire per mancanza di capacità e di mezzi. E questa è la cosa più triste che potrebbe accadere ad un compagno.
L’azione internazionalista
Di fronte alla guerra e al massacro degli insorti, la proposta anarchica non può che essere l’azione internazionalista. Essa è prima di tutto il rifiuto di adeguarsi a un campo o all’altro, considerato il «male minore», o di applaudire agli interventi militari di grandi potenze contro o a favore dell’uno o dell’altro campo. L’azione internazionalista in un tale contesto consiste fondamentalmente nel difendere l’insurrezione e la rivoluzione sociale di fronte alla reazione. Essa interviene lungo due assi fondamentali: il sostegno delle tendenze rivoluzionarie e antiautoritarie in seno all’insurrezione stessa, e l’attacco al dispiegamento repressivo e militare qui.
Pur non escludendo a priori la possibilità di intervenire in un’insurrezione altrove, pensiamo che l’azione internazionalista si debba anche concepire come diffusa e decentrata. Durante la rivoluzione del 1936, diversi anarchici erano partiti per lottare accanto ai loro compagni spagnoli. Anche se era possibile rafforzare la rivoluzione recandosi sul posto, altri compagni hanno evocato e tentato di appoggiare la rivoluzione estendendo il conflitto in altre contrade. Sia sotto forma di scioperi nei porti dove le navi cariche d’armi transitavano per foraggiare i fascisti in Spagna, sia con precisi attacchi contro interessi della reazione internazionale, o ancora intensificando e accelerando i progetti insurrezionali per scatenare le ostilità anche in altri luoghi. Se la prima modalità — l’intervento diretto nell’insurrezione — evidenzia una potenzialità di cui bisognerebbe ricostruire oggi le basi e le condizioni, la seconda — l’estensione insurrezionale delle ostilità e il sabotaggio degli interessi della reazione — si situa nel prolungamento di iniziative e di attività già esistenti, su differenti piani, aprendo uno spazio informale che oltrepassi le frontiere.
Di fronte alla ristrutturazione della repressione e al suo corollario militare e securitario, ci sembra possibile ed auspicabile ridisegnare i tratti di una progettualità anarchica insurrezionale. Perché la guerra e la ristrutturazione sono anche momenti, malgrado la schiacciante dimostrazione di forza del potere, in cui le difese immunitarie del sistema in qualche misura si indeboliscono ed esso mostra inevitabilmente le sue ferite aperte, cioè i suoi punti deboli. E sono anche questi i momenti propizi per far precipitare la situazione e contribuire a far scoppiare l’insurrezione.
Se questa progettualità può esplorare la strada di una lotta insurrezionale contro una nuova struttura repressiva, essa può, altrove, nello stesso luogo o nello stesso tempo, preparare il terreno per attaccare l’apparato repressivo e militare, l’industria bellica e la fabbrica della repressione. Ciò richiede tutto un lavoro di ricerca e di informazione, con dettagli sui luoghi e gli uomini della produzione di morte, i rapporti, i canali d’informazione e di comunicazione, i percorsi di approvvigionamento energetico e le catene di comando, per fornire vie di intervento e mettere a disposizione le conoscenze indispensabili all’attacco.
Gli obiettivi della distruzione insurrezionale di una realizzazione repressiva del potere e la destabilizzazione, attraverso una diffusione di attacchi, della sua produzione repressiva, e quindi della pace sociale, possono costituire in questi tempi instabili dei punti di orientamento nello sviluppo e nell’approfondimento di una nuova progettualità anarchica.
Contro la guerra, ma non disarmati
[Primavera 2015]