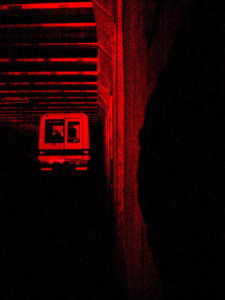Enzo Martucci
1924 — 1933: nove anni di lotta, di tensione, di spasimo. Segnano il periodo più burrascoso della mia vita, la fase acuta della guerra del reprobo contro tutti.
Rientrato in Italia in seguito ad una amnistia non potetti più uscirne. Nel 25 ero in carcere a Genova, nel 33, dopo cinque anni di ammonizione politica, mi trovavo al confino a Lampedusa. Rosa, l’affettuosa compagna che ave
va con me diviso, per sette anni, miseria, persecuzioni e tormenti, era morta, consumata da quella vita d’inferno. La mia famiglia mi aveva rinnegato, mia madre pagava con la sua rovina finanziaria e con l’abbandono del marito, l’amore per il figlio. Un patrimonio cospicuo da me ereditato da una vecchia zia, se n’era andato in pochi mesi. Lampedusa accoglieva, nella sua opprimente desolazione, il tragico relitto d’una nave d’alto mare. Tutte le stelle erano svanite, non rimanevano che le tenebre cupe ed il sogghigno della sorte.
Prigioniero in un’isola triste, cacciato fra la marmaglia nel luridume dei cameroni, scontavo con le più atroci torture il folle ardimento della rivolta, il desiderio inaudito di trasformare la vita, di adattare il mondo a me, ai miei sogni prometei, alle mie brame romantiche. E ricordavo, con amarezza, gli ultimi colpi ricevuti, le aggressioni degli squadristi, la persecuzione politica che aveva preceduto la relegazione, e le infami montature ordite a mio danno da un perfido poliziotto, vicequestore di Caserta, che s’era distinto nel vomitare calunnie e nell’imbastire processi a carico del reietto. Intanto nuovi dolori si aggiungevano a quelli vecchi e io mi torcevo fra le catene che m’entravano nelle carni e sentivo, prepotente, il bisogno di liberarmene per ricacciarmi nella lotta e colpire tutto e tutti.
Un tentativo di fuga dall’isola falli. Un pescatore che doveva accompagnarmi con la sua barca in Tunisia mi spillò del denaro, poi mi denunziò. Fui immediatamente trasferito a Tremiti e nell’arido scoglio che strapiomba a picco sulle onde dell’Adriatico, non trovai che rifiuti umani, confinati politici o comuni, privi di personalità, di sensibilità, d’ideale.
Nauseato dall’ambiente a cui non riuscivo ad adattarmi, esasperato dalle restrizioni che il confino imponeva, decisi di rinnovare il tentativo di Lampedusa e, all’uopo, m’intesi con Giuseppe Boretti. Giovane intelligente, nato come me in una famiglia borghese e dotato di cultura non scarsa, Boretti era il solo col quale potessi in quell’orribile luogo, scambiare qualche parola. Però il suo fanatismo marxista, il suo settarismo ad oltranza, lo rendevano antipatico e facevano si che le nostre discussioni degenerassero spesso in aspri litigi.
Educato in un collegio di gesuiti, poi convertito al comunismo, questo figlio o nipote di generale aveva l’anima inaridita dai precetti di Loyola e di Marx e, con la sua mancanza d’ogni sentimento e d’ogni umanità; con la passiva ubbidienza all’idea fissa che lo dominava, accresceva la mia avversione per quelle due rigide discipline che snaturano l’uomo e lo trasformano in un cieco strumento al servizio del cattolicesimo o del bolscevismo.
A ventidue anni egli ignorava l’amore: non sentiva il bisogno della donna. Non concepiva l’amicizia e lo confessava francamente. Un giorno mi narrò che a Milano, qualche anno prima, mentre lui ed Amendola scendevano da un’auto, furono circondati da un gruppo di poliziotti che volevano arrestarli. Amendola si lanciò contro i questurini e impegnò una colluttazione. Invece lui, il rampollo di generale, se la diede a gambe e si salvò con la fuga.
« Ma fu una viltà da parte tua — gli osservai — abbandonasti un amico nel pericolo, lo lasciasti solo alle prese con molti. Avresti dovuto rimanere al suo fianco, batterti e cadere o salvarti col compagno ».
«Come sei fregnone — mi rispose abbozzando un sorriso di superiorità — rimanendo sarei andato in galera e non avrei potuto servire per lungo tempo il partito. Fuggendo avrei conservato la libertà e la possibilità di continuare a rendermi utile al comunismo. Mi conveniva, quindi, la fuga. Cosa m’importa degli amici? E che cosa sono? L’essenziale, per me, è il partito ».
Un’altra volta mi disse che se fossi capitato con lui in Russia mi avrebbe immediatamente denunziato e fatto arrestare.
«E avresti questo coraggio? — replicai — siamo stati al confino insieme, abbiamo diviso lo stesso dolore. Ora cerchiamo fuggire di qui sfidando rischi ed avversità che dovremo affrontare uniti. E tu, « dopo, metteresti nelle mani dei poliziotti rossi chi ha lottato e sofferto con te?».
« Si, lo farei — rispose egli decisamente — Tu non sei un anarchico come Failla, un anarchico della mezza misura col quale noi comunisti possiamo intenderci. Tu sei un anarchico vero, un nemico del comunismo, e dobbiamo annientarti. Non sai che, per servire la mia idea, farei fucilare anche mia madre? ».
Talvolta, mentre sorbivamo il caffè nel bar di Angelina, io guardavo quel giovane seduto di rimpetto, dall’altro lato del tavolo, e mi sembrava di trovarmi dinanzi al seggio del presidente di un tribunale bolscevico, di un Fouquier-Tinville rosso che stava per condannarmi alla fucilazione. Il suo volto era troppo severo per la sua giovine età: dietro i cristalli degli occhiali a stanghetta la fiamma cupa del fanatismo bruciava in uno sguardo spietato. Sguardo da domenicano dell’Inquisizione, da sterminatore di eretici o pure da giacobino del terrore o da procuratore generale nei sinedri di Stalin.
Boretti mi definiva un romantico decadente e, qualche altra volta, anche « un viveur depravato che si è servito della tribuna rivoluzionaria per passare nel letto delle lavoratrici di Cassano d’Adda ».
Io lo chiamavo un prete rosso e gli consigliavo il riposo nelle brande degli agenti della Ghepeù i quali, con i metodi di Sodoma, gli avrebbero iniettato nuovo ardore bolscevico.
C’ingiuriavamo spesso e l’irriducibile opposizione delle idee e dei temperamenti, scavava fra noi un abisso profondo. Però avevamo bisogno l’uno dell’altro. Io avevo trovato chi, dietro compenso finanziario, ci avrebbe fornito la barca con la quale saremmo fuggiti in Dalmazia. Egli non disponeva di mezzi per allontanarsi dall’isola, ma poteva procurare le cinquemila lire che mi erano state chieste del pescatore con cui trattavo. Il piano falli perché il denaro, che doveva giungere clandestinamente, non arrivò. Dopo poco Boretti fu chiamato alle armi e, dall’isola d’Elba, dov’era stato mandato, riuscì a passare in Corsica. Io rimasi a Tremiti e subii le più severe restrizioni da parte della direzione che aveva intuito qualche cosa del progetto di fuga.
Passarono tre o quattro mesi e il tentativo che non ero riuscito ad eseguire, per mancanza di soldi, fu invece osato da altri due confinati politici. L’uno, un certo S. detto l’inglese perché aveva trascorso la sua giovinezza in Inghilterra, si trovava a Tremiti per sospetto di spionaggio a favore del governo britannico. M’inspirava una violenta antipatia per il suo carattere ipocrita e melato ed anche per l’attribuitagli qualità di spia.
Conservatore accanito come sa essere soltanto chi è stato educato nei collegi londinesi, trescava, malgrado ciò, coi comunisti nella speranza di servirsene al momento buono. I truculenti seguaci di Stalin, gli sbracati rivoluzionari, lucidavano le scarpe di quella caricatura di lord che, nella sua inamidata rispettabilità e secondo le regole del liberalesimo inglese, si degnava onorarli con qualche sorrisetto a fior di labbra che esprimeva la benevolenza del padrone di larga manica ai servi zelanti. E gli araldi del sovvertimento universale si facevano in quattro per andare a comprare i pasticcini e la marmellata al baronetto di Albione il quale, nella sua squisita munificenza, largiva all’uno dei lacche i francobolli per la collezione, all’altro i soldini per il tabacco e ad un terzo un orologio fuori uso.
Disponendo di qualche biglietto da cento e vincendo la formidabile paura che travagliava il suo cuore non certamente leonino, l’illustre rappresentante di SUA GRAZIOSA MAESTÀ tentò la fuga, spronato dal miraggio dei ristoranti lussuosi che, sulle rive del Tamigi, offrono ogni comodità ed ogni benessere a chi paga con i soldi, sia pure, dell’Intelligence Service.
Al suo tentativo di evasione si uni Cesare Neri che, essendo giunto pochi giorni prima nell’isola di Tremiti e non conoscendo quale razza di esemplare etico fosse il tacchino dai cinque pasti, partecipò alla impresa trascinato dal suo spirito avventuroso e dall’amore del pericolo.
Neri era uri tipo diverso dall’inglese. Passionale ed impulsivo, ribelle e manesco, come un romagnolo di puro sangue, sempre pronto ad accendersi come un fiammifero ma sincero e leale, conquistò, di colpo, la mia simpatia. Il giorno in cui giunse al confino, appena entrato nel camerone, dichiarò a quanti vi si trovavano:
« Ragazzi, io sono fascista e convinto delle mie idee. Ve lo comunico subito affinché sappiate con chi avete da fare. Se volete avvicinarmi e rispettare le mie opinioni, come io rispetterò le vostre, tanto meglio. Altrimenti ognuno tirerà per la sua strada senza dare disturbo agli altri ».
Entusiasta della sua fede ma alieno, come me, da ogni settarismo, egli mi avvicinava sebbene gli avessi, con altrettanta franchezza, dichiarato che ero anarchico. Io preferivo la compagnia di Neri, fascista, a quella dei comunisti; Neri si accostava a me e manteneva a distanza altri tre o quattro confinati che si dicevano fascisti e facevano le spie della direzione.
Non conoscendo l’inglese, il romagnolo accettò la sua proposta e tentò la fuga con lui. Il pescatore che doveva portarli via, li vendette alla questura. Mentre si allontanavano dall’isola in una barca, un’altra, carica di poliziotti, usci da un’insenatura, in cui s’era tenuta nascosta, e sbarrò la strada ai fuggiaschi. Qualche colpo di moschetto fu tirato, l’inglese, tremando come una foglia, si buttò, faccia a terra, nel fondo della barca e Neri, scattando in piedi, gridò agli agenti:
« Sparate a questi c……, figli di cani ».
Arrestati e tradotti nel carcere di Manfredonia, furono condannati a tre mesi di prigione. Quando ritornarono nell’isola erano irriconciliabili nemici: in galera avevano litigato e S. covava un odio sordo contro Neri.
Giunse intanto l’avvocato Giacomo Costa, massone, socialisteggiante, ex deputato di Napoli, gran venditore di fumo, ipocrita ed opportunista, diplomatico e posatore come quel bacato parlamentarismo che tanto bene rappresenta. Ben presto i nostri rapporti divennero tesi perché io non riuscivo a sopportare le sue arie e tutte le panzane che spacciava per darsi importanza, e lo ribattevo ogni volta.
Un giorno, nell’osteria nella quale pranzavamo, per fare sentire agli astanti ch’egli aveva conosciuto Lenin, mi disse:
« L’anarchia è irrealizzabile. Me l’ha confermato anche Lenin »,
« Secondo lui. Ma dove ve l’ha detto? ».
« In Svizzera ».
« Quando? ».
« Nel 1925 in occasione del nostro ultimo incontro ».
« All’anima della balla! Lenin ha abbandonato la Svizzera nel 17 e non si è più mosso dalla Russia fino alla sua morte che è avvenuta nel 23 o 24 ».
« Ma se vi dico che nel 25 l’ho visto a Losanna …..».
« Si, il padreterno gli aveva dato il permesso perché venisse a parlare con voi ».
Un’altra volta, nella stessa osteria, cominciò:
« Quand’ero ministro delle finanze a Fiume, durante l’occupazione dannunziana, redassi lo Statuto della Reggenza del Carnaro che poi D’Annunzio approvò ».
« Già — osservai — voi dettavate a Alceste De Ambris scriveva. Ma quando la finirete di spararle grosse? ».
Costa mi poteva vedere come il fumo negli occhi, ma faceva la corte a Neri perché sapeva che questi era amico di Arpinati. Contemporaneamente lisciava S. pensando che anche l’Intelligence Service è una potenza ed occorre, quindi, cattivarsi le grazie dei suoi agenti.
Una mattina, nella piazzetta del Castello nella quale si trovano gli uffici della direzione, eravamo rimasti a passeggiare soltanto io Neri e Costa. Quest’ultimo ci raccontava che aveva rifiutato il portafogli dell’Interno nel gabinetto Bonomi e la presidenza del Consiglio quando Facta rassegnò le dimissioni. Neri lo ascoltava, io guardavo, con occhio cupido, le forme giunoniche della bella Assuntina, la giovine lavandaia che sciacquava la biancheria fuori casa sua.
« Pochi mesi or sono — diceva Costa — ho inviato al duce un documento importantissimo, venuto in mio possesso grazie alle relazioni influenti che ho negli ambienti della politica internazionale. Da questo documento risulta che il greco Politis è stato al servizio del Negus. Mussolini, accusandone ricevuta, mi ha scritto: «Caro Costa, ti ringrazio del grande servizio che hai reso alla patria ».
Assuntina s’era ritirata nel suo tugurio sottraendo al mio sguardo la procace rotondità del suo seno voluminoso. Stizzito, mi sfogai con Costa:
« Mussolini vi ha risposto diversamente. Egli vi ha scritto: « caro Costa, tu dici balle ed io, per punirti, ti manderò al confino ».
L’onorevole panzerotto, com’io napoletanamente lo chiamavo, assunse un’aria indignata.
« Con voi non si può fare un discorso serio. Siete cosi insolente…..».
Non terminò la frase perché un confinato comune che, dopo aver passato dieci anni a Portolongone, era divenuto a Tremiti segretario particolare del direttore della colonia, si avvicinò a Neri.
« Voi sparlate di me — gridò — ma sappiate che vi farò provare i miei cazzotti ».
Parlare di cazzotti a Neri era come invitarlo a letto con una bella ragazza. Il reduce di Portolongone non aveva nemmeno finito la minaccia che un formidabile diretto lo raggiunse nel viso e lo mandò a battere con la testa contro il muro. Sanguinante e contuso egli non tentò nemmeno reagire e se ne andò a farsi medicare all’infermeria. Dopo pochi minuti giunsero i poliziotti o arrestarono Neri. Rimasto solo m’informai e venni a capo della macchinazione ordita a danno del romagnolo. L’inglese aveva spinto F. a provocare Neri sapendo che costui, col suo carattere impulsivo, avrebbe menato le mani e sarebbe finito in galera. Subito dopo il fatto due comunisti che non erano stati presenti alla lite ma che il perfido inglese aveva indotto alla falsa testimonianza con la mancia di venti lire, dichiararono al brigadiere di pubblica sicurezza:
« Noi ci trovavamo nella piazza quando è passato F. Egli non ha detto nulla a Neri, non l’ha provocato in nessun modo. Invece il fascista gli è saltato addosso, non appena l’ha visto, e l’ha picchiato ».
Costa, interrogato a sua volta, se la cavò con la solita diplomazia. Non accusò Neri, ma non scontentò S. Rese un dichiarazione sibillina che nuoceva, in fin dei conti, all’arrestato.
L’unico che ebbe il coraggio di dire la verità al direttore della colonia fui io. Gli confermai che i comunisti non erano stati presenti e avevano deposto falsamente. E quanto compresi che non voleva prestar fede alle mie parole, gridai:
« Lei perseguita Neri perché, a Roma, ha schiaffeggiato Starace. Perciò accoglie ciecamente le menzogne dei suoi nemici. Ma si ricordi che ciò che le ho detto lo ripeterò al procuratore del re ».
L’uomo dell’Intelligence Service, per sbarazzarsi dell’avversario, aveva messo a profitto la condiscendenza di F., il rancore maligno che il direttore della colonia nutriva per Neri e la venalità e l’odio settario dei comunisti.
La montatura portò il romagnolo in galera, ma io spiegai i fatti al pretore di Manfredonia, produssi le prove delle mie asserzioni e Neri, dopo un mese, fu assolto.
All’inglese sputai in faccia il mio disprezzo nel caffè di Angelina. Non osò reagire e, torcendo il collo di gallinaccio, buttò giù tutte le ingiurie che gli lanciai sul viso. Dopo qualche tempo cercò vendicarsi ordendo contro me un’altra subdola macchinazione che, fortunatamente, sventai. Coi comunisti non usai parole migliori di quelle di cui m’ero servito con S.
« Voi dite di non riconoscere la legge e lo Stato borghese e poi vi offrite a questa legge, come testimoni falsi, per mandare un uomo in carcere. Non vi sembra che ciò sia un’incoerenza, oltre che una viltà? ».
«Niente affatto — risposero — perché Neri è fascista e quando si tratta di colpire un avversario politico, noi ci serviamo anche della legge borghese e facciamo la spia. Questo è machiavellismo».
Dovetti allontanarmi perché il vomito mi soffocava. Io sono un discepolo di Stirner e di Nietzsche, un amoralista convinto, e credo con La Rochefoucauld che il male ha, come il bene, i suoi propri eroi. Comprendo Alessandro Magno che conquista l’Oriente e muore di stravizi a Babilonia, Nerone che, per soddisfare una fantasia artistica, fa incendiare Roma, Napoleone che insanguina l’Europa sognando il dominio mondiale, Bonnot che saccheggia le banche e cade eroicamente a Choisy le Roi, combattendo da solo contro cinquecento poliziotti. Comprendo il tiranno come il ribelle, l’io che si afferma nella libertà, ma disprezzo lo schiavo come la spia, l’io che si umilia, che striscia. Ammetto il male che rende grandi, anche quando non è fortunato, il male che traduce il conato prometeo, la lotta strenua contro il mondo; ma detesto l’abiezione che riduce l’uomo simile ad un verme e lo piega nell’accettazione dell’esistente di cui sfrutta i lati più turpi. Barabba non mi nausea, ma Giuda mi fa schifo. E quest’è, per me, questione di sentimento, non di morale.
I comunisti invece preferiscono l’altro male, quello codardo, avvilente. Dopo pochi giorni che avevano mandato in galera Neri, denunziarono un vecchio repubblicano, un certo Ragazzini, che s’era lasciato sfuggire parole offensive all’indirizzo del re. Il vecchio, in seguito alle delazione, si buscò tre anni e mezzo di carcere. E i seguaci di Stalin si liberarono, in tal modo, di un odiato avversario che non osavano affrontare per paura del suo coltello.
L’onorevole panzerotto, rotondo ed occhialuto come conviensi ad un futuro presidente della repubblica socialista, si mise a concorrere, in materia di spionaggio, coi sanculotti bolscevichi e col subdolo inglese. Per me non nutriva simpatia perché gli spiattellavo sul viso le più dure verità. Vantando amicizie e aderenze al tribunale di Foggia, voleva scroccare cento lire ad una povera donna che viveva nella miseria e aveva iniziato procedimento per la separazione legale dal marito, farabutto e prepotente. Io che, gratuitamente, ero stato l’estensore del ricorso di quella infelice, quando seppi che Costa, per una semplice raccomandazione, pretendeva denaro, non gli feci dare nulla. Panzerotto lo seppe e giurò vendicarsi.
Per rendermi geloso attirò in casa sua Assuntina, promettendole un compenso finanziario e la sua influente protezione di autorevole uomo. Poi mi fece dire, per mezzo del suo segretario, che aveva chiamato la ragazza per provocare me. Di rimando assicurai il segretario che, prima di sera, avrei rotto gli occhiali dell’onorevole. Costa, ricevuta l’ambasciata, corse immediatamente in direzione e mi denunziò. E il direttore, che mi vedeva come i cani vedono i gatti, mi fece arrestare e tradurre, in punizione, nella vicina isola di San Domino.
Panzerotto, dopo pochi giorni, fu trasferito a Lampedusa e di li fuggi all’estero. E in Francia, fra i fuorusciti, si atteggiò a vittima del fascismo e ad eroe evaso dal confino. Ma non narrò che a Tremiti si era dedicato alla delazione ed aveva, per sua vergogna, esposto alle rappresaglie poliziesche un altro confinato ben pili ribelle di lui.
E. Martucci “La setta rossa”